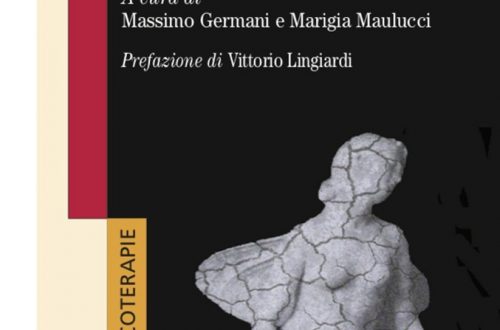Dallo psicodramma moreniano allo psicodramma junghiano
CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA
Corridore Alessandra
INDICE DEL CORSO MONOGRAFICO
- Introduzione
- Il teatro della spontaneità
- Lo psicodramma da Freud a Lacan
- Lo psicodramma come teatro di immagini
- Conclusione
- Bibliografia
INTRODUZIONE
La tragedia è l’imitazione di un’azione seria e completa,
avente una certa ampiezza di svolgimento, espressa in bella lingua,
che, suscitando la pietà ed il terrore, giunge
a placare questi due sentimenti, sublimandoli. (Aristotele)
Moreno definisce lo psicodramma il luogo in cui viene messa in scena la psiche. Dopo di lui la terapia psicoanalitica, che prima era relegata esclusivamente al lettino dello psicoanalista, si fonde con l’arte teatrale, diventa dramma, il dramma della psiche.
In questo lavoro ripercorreremo alcune delle tappe che hanno caratterizzato la genesi e lo sviluppo della tecnica psicodrammatica, attraverso le teorizzazioni di terapeuti di gruppo di orientamento freudiano, lacaniano e junghiano, mettendo in evidenza come possano esserci punti di vista in comune tra impostazioni così diverse.
Nello psicodramma, affermava Moreno, si fa teatro, dunque esperienza artistica, nella quale i membri del gruppo diventano gli attori di un dramma che non è finzione ma rappresentazione di stati d’animo che entrano in scena, con spontaneità ed autenticità, nel loro essere richiamati alla memoria, rievocati. E nel momento della recitazione non esiste più il passato come modello da riprodurre, ma è il presente che vive, hic et nunc. Lo psicodramma è vera esperienza di vita.
Lo si potrebbe leggere attraverso l’ottica della reminiscenza platonica. Platone non apprezzò molto l’esperienza artistica poiché la considerava una mera copia della copia del Mondo delle Idee, ma parlò anche della possibilità umana di ritrovare nella propria anima i concetti eterni e immutabili appartenenti al Mondo Iperuranio. È questo il senso della reminiscenza, che nello psicodramma può verificarsi solo se la rappresentazione non si limita ad essere una copia dell’esperienza vissuta nella realtà della vita quotidiana, solo se l’anima realmente e concretamente prende corpo e vive in quel momento ed in quel luogo liberando la sua vera essenza.
Moreno pone l’accento sulla funzione catartica della rappresentazione teatrale la quale libera la spontaneità dell’individuo dai vincoli della vita di ogni giorno, dai condizionamenti della società che surgela le idee ed i sentimenti come gli alimenti, scrive Anzieu. Hillman, che in Jung ha trovato il fondamento della sua teoria, chiamerebbe questo gioco teatrale fare poiesis, dare spazio e vita alle immagini psichiche, fare anima.
Ma il termine catarsi ha radici archetipiche. Aristotele, a proposito della capacità terapeutica dell’arte, parlò di catarsi estetica, cioè di ‘purificazione’ del corpo e dell’anima. Una concezione che trova le sue origini nelle antiche cerimonie di purificazione degli iniziati ai misteri Eleusini. Moreno si differenzia da Aristotele, scrive Anzieu, poiché estese la liberazione catartica dallo spettatore all’attore.
Basandosi sulle riflessioni di Jung si può estendere la catarsi alle immagini, considerandola come parte di un rito di purificazione che produce la liberazione non dalle ma delle immagini. Non a caso nell’opera alchemica, alla fase della purificazione dopo la morte, segue quella della liberazione. E non a caso anche l’alchimia è considerata un’arte.
Con la nascita dello psicodramma analitico la tecnica moreniana si va a fondere con le teorie di matrice freudiana. La funzione catartica non è più l’elemento fondamentale poiché assume importanza la funzione analitica. Si passa dal piano della concretezza al piano simbolico.
In questo panorama Anzieu intuì l’analogia che ci può essere tra le rappresentazioni psicodrammatiche e le rappresentazioni oniriche, tra lo psicodramma e il sogno. Questa sua concezione si avvicina molto a quella junghiana del sogno e della psiche come insieme di immagini, che Jung non chiama ‘rappresentazioni oniriche’ ma ‘immagini oniriche’.
Anzieu afferma che i soggetti umani vanno ai gruppi nella stessa maniera in cui durante il sonno entrano in un sogno. Dal punto di vista della dinamica psichica, il gruppo equivale al sogno. Dunque considera il sogno, e la psiche che lo determina, come molteplicità.
La Croce scrive che l’individuo può essere considerato come un gruppo più o meno integrato di personaggi e di istanze. Nonostante affermi infatti che nello psicodramma ‘non si fa gruppo’, ma analisi individuale in gruppo, quando si trova a parlare di individuo in senso psicologico, e quindi di psiche, lo fa secondo un’ottica di molteplicità.
Anche per Jung la psiche è molteplicità, è politeismo
di immagini. Ogni evento psichico, come una storia o un racconto, ha una
trama e dei personaggi, delle immagini che vi agiscono ed interagiscono. E nel teatro
dello psicodramma la molteplicità dell’anima di ogni partecipante
si fonde con quella del gruppo nel dar vita a trame sempre nuove, nel mettere in
scena la psiche.
IL TEATRO DELLA SPONTANEITÀ
A noi può andare il merito di aver messo su
La psiche, che in origine veniva dal gruppo, dopo un processo
di riconversione sul palcoscenico impersonato da un attore
ritorna al gruppo nella forma dello psicodramma . (Moreno)
“Bene, dottor Freud, io parto da dove lei finisce. Lei incontra le persone nel contesto artificiale del suo studio (…). Lei analizza i loro sogni. Io cerco di dar loro il coraggio di sognare ancora. Io insegno alla gente la parte di Dio” (Moreno, Manuale di psicodramma, 1, p. 66). Questa frase, che Jacob Moreno racconta di aver pronunciato nel 1912 in occasione di un incontro con Freud, è passata alla storia dello psicodramma ed è stata interpretata in maniera controversa. Nei primi decenni del secolo, ricorda Rosati, sembrò presunzione quella del giovane Moreno di contrapporre il suo psicodramma alla psicoanalisi; ma successivamente i commenti passarono dall’indifferenza al sarcasmo, alla critica ed alla riscoperta del metodo psicodrammatico (cfr. Rosati, L’attivazione dell’immagine nello psicodramma junghiano, p. 580).
Jacob Moreno nacque nel 1892 a Bucarest, in Romania. Studiò medicina a Vienna e lì condusse, tra il 1917 ed il 1925, i suoi primi esperimenti nell’ambito delle relazioni interpersonali. Si occupò di psicologia sociale ed è a lui che si deve l’invenzione del metodo sociometrico. Si addentrò anche nel campo della psicoterapia di gruppo dando vita al sociogramma ed allo psicodramma,basati sulla messa in scena di ruoli e sulla improvvisazione teatrale(cfr. galimberti, Psicologia,p. 663). Inizialmente si dedicò alla creazione di gruppi infantili di improvvisazione (1910-14). Poi, come medico dell’esercito, ebbe occasione di osservare la vita e l’organizzazione sociale spontanea di un campo di deportati durante la prima guerra mondiale.
Negli anni 1913-14 Moreno si occupò del reinserimento delle prostitute anche con sedute di discussioni libere in piccoli gruppi. In questa occasione si rese conto di come il gruppo costituisse in sé una realtà specifica ed avesse una propria struttura e, soprattutto, di come ogni partecipante del gruppo potesse diventare un agente terapeutico per l’altro (cfr. Anzieu, Lo psicodramma analitico del bambino e dell’adolescente, pp. 28-9). Guidato nel corso delle sue sperimentazioni anche dall’influenza di Stanislawsky, teorico del teatro e regista russo (Mosca, 1863-1938), nel 1921 fondò un vero e proprio teatro di improvvisazione (Stegreiftheater) in cui vigeva la regola della spontaneità.
Egli, “direttore del gioco, ma senza giocarvi lui stesso, proibisce agli attori di simulare dei personaggi: in questa maniera trasfonde in loro uno slancio interiore che permette ad essi di rivelarsi agli altri nella loro verità” (Anzieu, il gruppo e l’inconscio, p. 68).Questa esperienza gli fu utile poiché gli permise di prendere coscienza delle possibilità terapeutiche che offriva la rappresentazione. Si rese conto della possibilità di liberare, attraverso l’azione scenica, la spontaneità creativa dell’individuo soffocata dal ruolo sociale (cfr. Galimberti, Psicologia,p. 663). La spontaneità, infatti, è uno dei capisaldi dello psicodramma moreniano. Anzieu, a proposito dell’importanza di questo elemento nella società contemporanea, scrive: “Nella sua vita di ogni giorno, con i suoi superiori, i colleghi, i subalterni, con i figli e i vicini, l’uomo ha bisogno di liberare la sua spontaneità soffocata dalle discipline della scuola, della famiglia e della società, dalla tendenza fastidiosa della nostra civiltà a surgelare le idee e i sentimenti così come gli alimenti. Sotto questa nuova forma, lo psicodramma diventa uno strumento di perfezionamento personale” (Anzieu, il gruppo e l’inconscio, p. 70).
Nel 1925 Moreno portò negli Stati Uniti la sua ricchezza di esperienze. Lì iniziò a praticare la professione di psichiatra, di insegnante e continuò a dedicarsi ad una intensa attività di sperimentazione. Morì a Beacon, New York, nel 1974.
Lo psicodramma di Moreno si occupa dei problemi degli individui, attraverso una loro ri-attualizzazione e messa in scena. Prevede che le persone che partecipano al gruppo abbiano due funzioni differenti: essi fungono sia da compagnia teatrale sia da pubblico.
Scrive Claudio Neri: “In qualche centro specializzato o istituzione è stata innalzata una piattaforma, che serve come palcoscenico, sul quale i membri del gruppo mettono in scena a turno i loro problemi. Il paziente, scelto come protagonista, facilita gli aiutanti, che egli stesso ha selezionato tra gli altri membri del gruppo, nella assunzione del ruolo loro assegnato, descrivendo in modo molto dettagliato la scena che vuole recitare. Di tanto in tanto, il terapista-regista può dare istruzioni a qualcuno dei partecipanti, che si trova nella posizione di pubblico, di entrare nel ruolo del protagonista (rovesciamento dei ruoli tra ‘attori’ e ‘pubblico’). In tal modo, nella discussione, che segue la messa in scena, parecchie persone possono esprimere una loro opinione, basata su un’esperienza diretta” (Neri, Gruppo, p. 83).
Le relazioni che si instaurano tra i componenti del gruppo di psicodramma possono essere riassunte con una sola parola: tele. Il termine tele viene dal greco e significa da lontano, a distanza.Sta ad indicare il legame elementare esistente sia tra individui sia tra individui ed oggetti, il fattore determinante, la configurazione sociale. Rappresenta la più piccola unità dei sentimenti sociali, misurabile in termini sociometrici.Scrive Moreno stesso che tele rappresenta l’equivalente scientifico dell’Inconscio, il cemento che tiene insieme gli individui e il gruppo. In esso convergono la coesione, la comunicazione, i processi di attrazione o repulsione del gruppo (cfr. Gasseau, Gasca, Lo psicodramma junghiano, p. 165).
Oltre agli attori ed alle loro dinamiche lo psicodramma moreniano prevede la presenza di alcuni elementi essenziali che sonola scena in cui si svolge l’azione, un protagonista della rappresentazione, colui che ha esposto la sua storia, il regista, che ha funzioni di produttore, terapeuta ed analista, edei componenti del gruppo usati nella seduta come estensioni del regista e del protagonista, denominati io ausiliari. Essi “hanno la funzione di recitare quelle parti di cui il paziente può aver bisogno per presentare adeguatamente la propria situazione (…) dando corpo o a persone reali dell’ambiente del paziente come il padre, la madre o il figlio, o a figure simboliche come Dio, il Giudice o Satana caratteristici del mondo del paziente” (moreno in galimberti, Psicologia,p. 803). Compare anche la figura dell’uditorio “che, come il coro della tragedia greca, fa da eco al protagonista manifestando le proprie emozioni di fronte alle vicende rappresentate” (Galimberti, Psicologia,p. 802).
Moreno fu il primo a proporre il concetto di acting out, che in seguito, in campo psicoanalitico, assumerà un significato regressivo o difensivo. Il significato originario del termine si riferisce all’estrinsecazione, da parte di un attore, di un sentimento personale che va oltre la parte assegnatagli (cfr. Gasseau, Gasca, Lo psicodramma junghiano, p. 159). Per Moreno il ruolo dello psicodrammatista è quello di promuovere l’azione, di assumere un atteggiamento direttivo invitando i partecipanti ad agire verbalmente, con il contatto fisico e con l’espressione corporea, alla quale assegna una funzione catartica (cfr. Galimberti, Psicologia,p. 802). Yablonsky, che fece la sua prima esperienza di psicodramma con Moreno stesso, ricorda l’importanza che il suo maestro dava all’azione, e cita queste sue parole: “anche quando si cerca di spiegare un atto, l’azione viene prima. Non ci può essere spiegazione sensata senza che prima abbia luogo l’atto” (Yablonsky, Psico dramma, p. 21).
Un’altra caratteristica dello psicodramma moreniano è quella dell’hic et nunc, del qui ed ora. Già ho fatto riferimento all’elemento fondamentale della spontaneità, la spontaneità di quel dato momento in cui si svolge l’azione, e di quella data versione della propria esperienza che il protagonista sente come vera. Racconta Yablonsky: “Tutte le volte che al protagonista di una scena del passato veniva fatto di dire: ‘Quando avevo cinque anni amavo mia madre’, Moreno lo correggeva: ‘Io ho cinque anni ed amo mia madre’. Nello spiegare il ‘qui ed ora’ nello psicodramma, Moreno tenne a sottolineare che una persona non può agire più nel passato” (Yablonsky, Psico dramma, p. 21).
La realtà di cui si parla è una realtà del vissuto dell’individuo che si concretizza nel momento e nel luogo in cui viene recitata. Moreno diceva che la rappresentazione avrebbe avuto maggiore efficacia se fosse stata rappresentato in situ, nel luogo in cui si era verificata l’azione narrata dal protagonista, o altrimenti nel teatro allestito nella maniera il più fedele possibile alla realtà. Nonostante si cerchi di rendere l’ambiente della recita il più ‘veritiero’ possibile per aumentare l’effetto liberatorio (catarsi), il protagonista, continua Yablonsky, “ha diritto alla propria personale prospettiva della verità” (idem).La madre descritta nello psicodramma può assomigliare come può non assomigliare alla madre reale del narratore, ciò che è certo è che si tratta della reale percezione che egli ha di sua madre.
Attraverso l’inversione di ruolo tra gli attori, ma anche con il terapeuta, è possibile che l’attore principale veda se stesso attraverso gli occhi dell’altro. Moreno approdò a questa tecnica, ricorda Anzieu, quasi spontaneamente. Egli si riteneva terapeuta e guaritore di anime. Faceva riferimento a Socrate poiché in lui vedeva un pioniere dello psicodramma, e le sue prime sedute avevano il sapore dei dialoghi socratici. “(Socrate) sceglieva come anti protagonista un carattere rappresentativo, il sofista. Utilizzando senza saperlo la tecnica del rovesciamento dei ruoli, innalzava il sofista e lo trasformava in maestro, mentre lui assumeva il ruolo dell’allievo che fa le domande … conducendo il sofista attraverso diversi dilemmi, provocava la partecipazione dell’uditorio e il dialogo terminava in una catarsi dialettica” (Anzieu, Lo psicodramma analitico del bambino e dell’adolescente, p. 24).
A questo punto ci si potrebbe chiedere in che modo i giochi di ruolo (che nella traduzione hanno perso il riferimento alla recitazione, evidente nell’inglese role-playng) dello psicodramma moreniano siano terapeutici. Ciò può avvenire poiché la spontaneità messa in scena, permette la catarsi delle emozioni. Moreno si era accorto di ciò nel 1923. In quell’anno una giovane attrice, Barbara, che recitava brillantemente le parti della ragazza timida o della donna angelicata, si scoprì che a casa, con il marito, sfogava tutta la sua aggressività dando vita a scenate volgari e disgustose. Moreno le propose di cambiare ruolo in teatro recitando parti di cameriera di caffè, di amante ansiosa, di moglie che brama vendetta, di prostituta o ubriacona, di donna dei bassi fondi. Dopo qualche tempo i suoi accessi d’ira nei confronti del marito cessarono e sembrò liberata dalla coazione alla violenza ed alla volgarità che prima regnavano nella sua vita quotidiana (cfr. Croce, Il volo della farfalla, p. 44).
Già Aristotele aveva parlato di liberazione, o catarsi (da catarsis che Racine ha tradotto con ‘purificazione’) dalle passioni che si agitano nello spettatore di fronte alla rappresentazione della tragedia. “Vivendo in maniera immaginaria – o piuttosto simbolica -, grazie all’eroe rappresentato sulla scena, lo scatenamento di queste passioni e la loro tragica conclusione, lo spettatore ne rimane curato e le supera. Moreno non ha inventato l’improvvisazione drammatica più di quanto Freud abbia inventato l’interpretazione dei sogni. L’umanità ne conosceva da lungo tempo l’esistenza e gli effetti. Ma nessuno prima di loro ne aveva chiarito la fragile arte, o aveva articolato dei concetti che rendessero trasmissibile la loro descrizione scientifica e l’utilizzazione oggettiva dei loro effetti. Il solo progresso da Aristotele a Moreno è consistito nell’estendere la liberazione catartica dallo spettatore all’attore restituendogli in questa maniera tutta la sua potenza” (Anzieu, Il gruppo e l’inconscio,p. 69).
LO PSICODRAMMA ANALITICO
TRA FREUD E LACAN
Nella vita psichica del singolo, l’altro è regolarmente presente come modello,
come oggetto, come soccorritore, come nemico, e pertanto,
in quest’accezione più ampia ma indiscutibilmente legittima,
la psicologia individuale è al tempo stesso, fin dall’inizio, psicologia sociale (freud).
L’inconscio è il discorso dell’Altro . (Lacan)
Dopo la seconda guerra mondiale alcuni analisti europei, più che altro francesi, si formarono per un certo periodo di tempo con Moreno, in America. Successivamente portarono lo psicodramma in Francia, ed in seguito in Olanda, in Belgio, in Inghilterra. Attraverso questi passaggi lo psicodramma di Moreno si modificò rapidamente tramite l’elaborazione e l’interpretazione di analisti e psicologi provenienti da scuole differenti. Nacquero diversi tipi di psicodramma con varie denominazioni. I più noti sono lo psicodramma triadico, in cui il setting è definito da tre elementi fondamentali che sono il gioco, l’ascolto analitico e la dinamica di gruppo, e lo psicodramma analitico (cfr. Croce, Il volo della farfalla,p. 45).
Nello psicodramma analitico le rappresentazioni non avvengono più in presenza di un pubblico. Viene messo da parte il metodo catartico proposto da Moreno poiché non lo si ritiene efficace per quanto riguarda l’azione trasformativa della struttura psichica profonda, cambia lo scopo stesso della rappresentazione che da catartico diviene interpretativo. L’interpretazione non riguarda larealtà rappresentata ma l’immaginario del paziente-protagonista sul piano simbolico. Per questo non diviene necessario proporre le rappresentazioni in situ come voleva Moreno.
Lo psicodramma psicoanalitico dà molta importanza al transfert ed alle identificazioni.
Nelle sedute sono vietati contatti fisici tra i partecipanti.
Esse si svolgono in ambienti che non ospitano accessori teatrali, con scansioni temporali fisse, e sono condotte da due analisti, di solito di sesso diverso, che hanno il compito di interpretare i conflitti che lo psicodramma evidenzia(cfr. Galimberti, Psicologia, p. 803).
Lo psicodramma analitico si differenzia a seconda della teoria analitica che vi è alla base. Eugénie e Paul Lemoine, agli inizi degli anni ’60, nell’ambito della Societé d’Etudes de Psychodrame Thérapeutique (S.E.P.T.) di Parigi, misero a punto un tipo di psicodramma che assunse il nome di ‘psicodramma freudiano’. Elena B. Croce, psicologa psicoterapeuta lacaniana, fu loro allieva. Ora fa parte della sezione italiana della S.E.P.T., costituitasi nel 1981 a Roma, che ha assunto in Italia il nome di Società Italiana di Psicodramma Analitico (S.I.Ps.A).
La Croce, nel suo libro intitolato Il volo della farfalla, scrive che lo psicodramma introdotto dai Lemoine fonda le sue premesse sulle teorizzazioni di Freud, ma ribadisce che, come è noto, Freud non si è mai occupato di psicodramma e quindi la definizione che spesso viene utilizzata per individuare un certo tipo di psicodramma – ‘psicodramma freudiano’ – appare alquanto ironica. Per evitare equivoci la psicologa preferisce utilizzare la definizione di psicodramma analitico, che può essere definito tale per la sua “attenzione privilegiata alle traversie del desiderio nel soggetto, all’emergenza dell’inconscio nei suoi più classici derivati e ad uno specifico lavoro sul transfert” (Croce, Il volo della farfalla,p. 46).
Il gruppo
Nel 1921 Freud pubblica l’opera Psicologia delle masse e analisi dell’io nella quale afferma che, anche se la psicologia fosse riuscita a raggiungere l’obiettivo di conoscere e quindi di vedere in trasparenza l’individuo, ci si stupirebbe ancora per le reazioni che esso ha nel contesto sociale. Freud stesso dunque riconosce che l’uomo può avere dal rapporto con il sociale degli stimoli molto peculiari.
Nello psicodramma analitico si realizza la situazione in cui l’individuo si trova a contatto con un contesto sociale, il contesto del gruppo, che è inteso in modo differente a seconda delle teorie che ha alla base.
Nell’impostazione proposta dalla S.E.P.T. non si fa gruppo. Elena Croce afferma: “il … gruppo risulta essere per noi … una serie di individui giustapposti, anche se reciprocamente condizionati, e cioè quello che Freud (1921) chiama ‘folla semplice’, una folla eterogenea. … si può dire che facciamo cure individuali in gruppo” (Croce, Il volo della farfalla,p. 46). Altri psicoanalisti si discostano in parte da questa concezione, ed uno di questi è Dider Anzieu.
Entrambi però fanno riferimento alla ricerca di unità che ogni individuo cerca sin da bambino. Anzieu parla della fase dello specchio in cui il bambino gioca davanti allo specchio con le immagini che si riflettono su di esso. La fase successiva è quella in cui riconosce negli oggetti visti nello specchio delle immagini, tra le quali riconosce anche la sua. Rimane a contemplarla affascinato, lo rassicura poiché gli permette di percepirsi come un’unità corporea “e gli dà un fondamento visibile della nozione del proprio Io” (Anzieu, Il gruppo e l’inconscio, p. 164). Questo processo, afferma la Croce, comincia a verificarsi dopo i sei mesi ed è strettamente legato alla richiesta del bambino dello sguardo altrui, del riflesso dell’altro in se stesso, del riconoscimento da parte della madre o di chi la sostituisce “che dà al riconoscimento della propria immagine più o meno unificata e autonoma da parte del bambino, un carattere di anticipazione rispetto alla sua realtà esistenziale e che imprime per sempre in lui questa necessità di dipendere dall’altro, dal modo (presunto) in cui l’altro lo vede, lo accetta, lo desidera” (Croce, Il volo della farfalla,p. 81). Lo sguardo della madre risponde alla richiesta del bambino di essere riconosciuto. Conferma che l’immagine riflessa nello specchio è proprio lui, e crea l’interesse a riconoscersi. Comincia così a formarsi quell’istanza che Freud definì Io, che precede la formazione delle altre istanze della psiche. Elena Croce, parafrasando Lacan, scrive che “Un essere umano, e cioè quello che siamo soliti chiamare individuo, non può autodefinirsi: nel farlo deve riferirsi a qualcun’altro” (ibidem,p. 85), l’Io ha bisogno di un Tu per affermare se stesso.
Per questo motivo lo psicodramma, che per la Croce rappresenta una terapia individuale che si attua in una situazione di gruppo, acquista grande valore.Non va sottovalutata la situazione molto particolare che si crea nello psicodramma, in cui ogni partecipante è esposto allo sguardo dell’altro che, diversamente dalla fase dello specchio, manda in frantumi il soggetto, condizione che si tramuta in un terreno fertile per una riorganizzazione dinamica dei diversi elementi.
Anzieu, pur ritenendo importanti le individualità dei membri del gruppo, si è interessato anche alle dinamiche gruppali. Egli scrive: “l’Io arcaico sussiste come garante dell’unità personale …, come garante dell’immaginario, e perciò fragile” (Anzieu, Il gruppo e l’inconscio, p. 165). È da qui che sviluppa la sua concezione sul gruppo nel quale l’individuo si trova faccia a faccia con partners che non conosce e che non lo conoscono, di numero superiore a quello dei suoi rapporti sentimentali abituali (famiglia, partner…) nei quali si sentiva protetto ed unito agli altri. Questa situazione può essere vissuta come una minaccia per l’unità personale, una messa in questione dell’Io. In una tale situazione ‘plurale’ il rischio è quello di “non esistere più per me stesso, di perdere ogni senso, lacerato tra tante diverse domande; il mio Io si sparpaglia, la mia bella unità immaginaria si frammenta, lo specchio è rotto in più pezzi che rinviano immagini (di sé) sfigurate e differenti. (…) Il gruppo riconduce l’individuo indietro, molto lontano, là dove non era ancora costituito come soggetto, là dove si sente disgregato” (ibidem, p. 166). Lo psicologo paragona il gruppo agli inizi ad un corpo a brandelli. C’è chi dall’angoscia del silenzio iniziale fugge all’indietro, rimanendo rigido ed assente, e c’è chi fugge in avanti reclamando programmi, cercando di comandare, lamentando l’inutilità delle riunioni.
Dopo questa prima fase, sempre utilizzando la metafora dell’organismo vivente, per fuggire dall’angoscia della disgregazione si elabora il sentimento del ‘noi’, ed è “la nascita d’una unità superiore ad ogni individuo e alla quale ogni individuo partecipa: il gruppo è nato … come corpo vivente” (ibidem, pp. 167-8). Questa metafora richiama alla memoria la storia del console romano Menenio Agrippa che, si narra, nel 500 a.C. mise fine alle discordie tra patrizi e plebei con una parabola in cui si affermava la necessità della collaborazione tra tutte le parti del corpo, sia delle membra sia dello stomaco, per la sopravvivenza dell’uomo, e quindi sia dei plebei sia dei patrizi, per mandare avanti lo Stato e per garantire il benessere di entrambi. Anzieu, però, paventa anche il rischio di quella che chiama illusione gruppale che al narcisismo individuale sostituisce quello gruppale. Essa può essere riassunta in espressioni tipiche come ‘siamo il gruppo più bello del mondo’. Claudio Neri ritiene che questo modo di reagire rappresenti uno spostamento difensivo rispetto al vero fine della psicoterapia: la messa in discussione di ciascun membro del gruppo personalmente. Si tratta di una reazione all’incapacità di stare in un rapporto, che può modificarsi soltanto al modificarsi di tale incapacità (cfr. Neri, Gruppo, p. 46). Non si tratta comunque di un elemento precipuamente negativo poiché la paura, l’angoscia e lo smarrimento iniziali sono le condizioni ideali per una nuova nascita ed un nuovo sviluppo (cfr. idem; Anzieu, Il gruppo e l’inconscio, pp. 314-7).
Anzieu paragona il gruppo ad un sogno. Parte dall’assunto di Freud che un sogno notturno è una realizzazione allucinatoria di un desiderio, e trasferisce questa definizione al gruppo. Riporta degli esempi dell’immaginario collettivo in cui il sogno è stato immaginato, per esempio nei casi dell’Utopia di Thomas Moore, dell’abazia di Thélème di Rabelais, del falanstero di Fourier, di les Copains di Jules Romains…, come la possibilità immediata di soddisfacimento del desiderio. Egli scrive: “Il gruppo, come il sogno, come il sintomo, è in ciascuno dei suoi episodi l’associazione di un desiderio e di una difesa” (ibidem, p. 203). “I soggetti vanno ai gruppi nella stessa maniera in cui durante il sonno entrano in un sogno. Dal punto di vista della dinamica psichica, il gruppo equivale al sogno” (idem). Se con il sogno si fa riferimento al desiderio individuale, questo nel gruppo diviene inter, trans-individuale. Entrambi permettono ai partecipanti di entrare in contatto con l’altro lato dello specchio, il lato inconscio (cfr. ibidem, p. 206). Per Anzieu, infatti, gli inconsci individuali, in una situazione gruppale, comunicano tra di essi (cfr. ibidem, p. 202).
Certo, il rischio è alto, continua, richiamando il fenomeno della folla. La folla è un contagio di emozioni e di credenze, un comportamento contraddittorio che per Le Bon è come quello di una donna. Per Hugo si tratta di una donna ubriaca, per Zola di una prostituta. Un’altra metafora assimila la folla ad un oceano, che è strettamente legata a quella della folla come madre.La folla-oceano è associata al rischio di essere inghiottita da se stessa, di annegare in se stessa (la madre divoratrice); è associata, allo stesso tempo, all’angoscia di essere calpestata da se stessa, e quindi perduta (nelle cure di una madre che dà calore, nutrimento e sicurezza) (cfr. ibidem, p. 180).
A questo punto dall’illusione gruppale è necessario passare alla fase della disillusione che consiste nella presa di coscienza del fatto che l’illusione aveva funzionato da strumento di difesa nei confronti della messa in gioco di se stessi, alla quale segue il riconoscimento dell’inconscio individuale. Anzieu riporta alcune esperienze personali di uscita dall’illusione gruppale, come per esempio in alcuni gruppi organizzati in ambito universitario, per i candidati al diploma di psicologia clinica per la laurea in psicologia. Con i suoi collaboratori impone l’obbligo agli studenti di partecipare a più gruppi di dimensioni diverse e caratterizzati da differenti metodologie, proprio per intervenire sul rischio dell’illusione gruppale. È interessante osservare le diverse reazioni, tra cui quella di un gruppo di studenti nel quale, nelle ultime sedute, emerge l’immagine della malattia mortale. Emerge il dubbio se sarebbe giusto dire ad un paziente che è affetto da una malattia mortale l’entità del suo male. Si gioca la scena tra l’ammalata ed il medico e poi quella tra l’ammalata e sua madre, scena che colpisce molto i partecipanti al gruppo. La seduta successiva inizia con la domanda: “’chi si è voluto far morire? …’. …si finisce per scoprire che la verità così temuta da tutti è che bisognava morire alla madre dell’infanzia, morire all’adolescenza, morire alla vita di studenti portata avanti per lungo tempo nell’ambiente chiuso e caldo dell’Università. È così che questo gruppo ha potuto iniziare il suo passaggio alla realtà sociale verbalizzando la propria esperienza della disillusione” (ibidem, p. 277).
Claudio Neri fa riferimento alle teorie di Anzieu, ma introduce un nuovo elemento, lo stadio della comunità dei fratelli. Cita J.-P. Sartre che intende il gruppo come un processo che passa dalla fase in cui è presente ‘un certo numero di persone’ a quella in cui le persone che formano il gruppo, parlando di loro stesse, possono dire ‘noi’ iniziando a stabilire rapporti di reciprocità. Tutto ciò non è in contrasto con le riflessioni di Anzieu. Neri distingue due punti di vista nell’ambito del lavoro analitico: quello che si riferisce ai fratelli, e quello che riguarda la comunità dei fratelli. Nel primo caso egli si rivolge al gruppo composto da singoli individui, verso i quali ogni partecipante può nutrire i sentimenti più disparati di invidia, ammirazione, protezione… (le proiezioni). La comunità dei fratelli invece costituisce il gruppo nel quale i componenti formano un’unità (cfr. neri, Gruppo, pp. 51-4) dinamica. Lo psicologo cita, in proposito, una frase di L.Lévy Bruhl: “I primitivi non comprendono che la terra sia oggetto di proprietà individuale. La terra in realtà appartiene – in senso assoluto – al gruppo sociale nel suo complesso, vale a dire all’insieme dei vivi e dei morti” (in ibidem, p. 54).
Il setting
In psicoanalisi il setting delimita un’area spazio-temporale in cui vigono della regole che definiscono ruoli e funzioni.Si tratta di una situazione specificamente costruita per l’analisi del vissuto affettivo del paziente, in un luogo che non sia quello abituale, della vita quotidiana (cfr. Galimberti, Psicologia,p. 262).Elena Croce lo paragona ad uno strumento musicale che ha una determinata forma e permette l’emissione di determinati suoni. La combinazione di essi, però, risulta pressoché infinita e dipende dalle preferenze e dalle capacità degli artisti. “L’invenzione del setting da parte di Freud serve a creare l’area di gioco e dell’illusione…” (Croce, Il volo della farfalla,p. 28). Esso è un insieme di più elementi che costituiscono il patto analitico, cioè il numero delle sedute, l’ammontare dell’onorario e le modalità di pagamento, i periodi di vacanza, ma sembra comprendere anche le regole della libera associazione e dell’astinenza. “Vale come aspetto strutturato e, in un certo senso, grammaticale; fissa, cioè, alcune regole ritenute indispensabili nell’ambio di quella data relazione, affinché il discorso possa svolgersi” (ibidem, p. 40).
La Croce cita J. Bleger che vede gli elementi del setting analitico come un ‘non processo’ (cfr. ibidem, p. 27). Anche Neri cita lo stesso autore riportando le sue definizioni di setting-istituzione, il ‘non processo’, e di setting-processo. Il setting-processo consiste nella serie di regole e procedure che permettono l’attivazione delle emozioni presenti nel gruppo, emozioni che non vanno agite (tranne che nel gioco) ma che emergono da ciò che viene detto nella seduta, e dal modo in cui viene detto. Un altro aspetto di questo modo di intendere il setting identifica due diversi stati mentali dei partecipanti all’analisi: quello del paziente coinvolto nelle emozioni e quello dell’analista attento a recepire indizi o segnali (cfr. Neri, Gruppo, pp. 225-6). Bleger, scrive Elena Croce, distingue nettamente il setting dell’analista, e quindi il suo atteggiamento di fedeltà al metodo analitico, dal setting del paziente che entrano in contatto, si confrontano e si affrontano, nel corso dell’analisi (cfr. Croce, Il volo della farfalla,pp. 27-8).
“Secondo molti autori il setting sembra … assolvere alla necessità di offrire al paziente un ‘oggetto stabile’, che si può omologare in qualche modo alle cure materne. Si dice, infatti, e si ripete con una certa insistenza, che il paziente procede accolto, ricevuto, contenuto nel setting come se questo venisse ad assumere una funzione analoga alle braccia della mamma e, pertanto, una funzione di holding nel senso winnicottiano: protezione e sostegno” (ibidem,p. 30). Elena Croce però, ancora citando Bleger, espone il rischio dell’immutabilità del setting che può creare nel paziente l’illusione, data da un desiderio infantile, di poter trovare in esso protezione dai pericoli del mondo, in una situazione magica in cui l’analista possa difenderlo da ogni nemico.Questo rischio può essere arginato soltanto se la cornice che costituisce il setting non diviene un compartimento stagno, una realtà totalizzante. Il setting è uno strumento della terapia, la Croce lo definisce una cerniera tramite la quale vicende ed emozioni vissute altrove acquistano diritto di parola. Da qui la riflessione sulle regole che rappresentano comunque, sia che vi si aderisca sia che si trasgrediscano, un punto riferimento stabile ed essenziale (cfr. ibidem, p. 38-40).
A questo punto sembra doveroso fare riferimento alle regole, già citate in precedenza, che caratterizzano lo psicodramma. Le regole che Anzieu assegna al paziente sono quelle della non omissione e della libera associazione, che consistono nel parlare liberamente delle cose così come si presentano ed a mano a mano che si presentano senza omettere nulla, per quanto sia possibile. L’altra regola è quella dell’astinenza che riguarda l’astenersi da ogni relazione personale con l’analista dentro e fuori dal setting. Anche l’analista è soggetto alle stesse regole. Risponde alle libere associazioni del paziente con una attenzione fluttuante e, se se ne presenta l’occasione, parla liberamente di ciò che ha compreso di lui. Nel corso delle sedute si astiene dall’ottenere soddisfazioni personali dal paziente (controtransfert) e, fuori dalle sedute, dal parlare con lui. Fondamentale è per Anzieu, come in genere per i freudiani, l’accordo sull’onorario che, simbolicamente, rappresenta il prezzo che il paziente deve pagare per la guarigione(cfr. Anzieu, Il gruppo e l’inconscio, pp. 27-8).
Lo psicodramma vero e proprio
Lo psicodramma è caratterizzato da due figure analitiche fondamentali, l’animatore e l’osservatore che, secondo Elena Croce, dovrebbero alternare i loro ruoli. È importante infatti che la funzione analitica venga distribuita su due persone reali, ciascuna delle quali presenta caratteristiche peculiari a livello di temperamento, di stile di ascolto o di intervento(cfr. Croce, Il volo della farfalla,p. 59).
L’animatore conduce la dinamica di gruppo e quindi è presente in maniera esplicita durante quasi tutta la seduta. Anzieu parla di una prima fase in cui i componenti del gruppo si trovano ad affrontare la resistenza passiva e la paura di doversi esporre. Con la guida dell’animatore dal silenzio iniziale emergono i sogni, le storie le associazioni di ognuno. I membri del gruppo mettono in comune le proprie angosce che circolano, come direbbe la Croce, o che fanno eco, come vorrebbe Anzieu. L’animatore poi sceglie una delle storie raccontate nel gruppo da drammatizzare, quella che ritiene che possa meglio contenere le tematiche e le immagini emerse nella seduta, oppure una storia significativa e chiarificatrice per una singola persona. Segue il momento del gioco in cui, attraverso lo scambio dei ruoli, i membri del gruppo hanno la possibilità di indossare i panni dell’altro. Dopo il gioco l’animatore chiederà a chi ha giocato o ha doppiato i vari ruoli di esprimere le sensazioni provate.
Le figure dell’animatore e dell’osservatore, come è stato già accennato, hanno il dovere della neutralità e dell’astinenza. Una delle ragioni consiste nell’evitare il rischio che cadano nell’illusione di essere membri del gruppo alla stessa stregua degli altri partecipanti, posizione nella quale talvolta il gruppo stesso tende a volerli mettere (cfr. Croce, Il volo della farfalla, p. 50).
In particolare l’animatore non deve stare al centro del gruppo, ma ‘ai bordi’ cercando di non offrirsi mai come modello ideale o come partner dei singoli membri o del gruppo stesso (ibidem, p. 58). La conduzione di un gruppo, scrive Anzieu, è caratterizzata dall’abilità dello psicologo di lasciarsi prendere dai fantasmi che in esso circolano, di ‘farsi coinvolgere’ senza, però, ‘essere coinvolto’, cioè senza rimanerne prigioniero; “in altre parole… partecipa senza essere ‘agito’ dai fantasmi ma accogliendoli, conoscendoli e comunicandone la conoscenza” (Anzieu, Il gruppo e l’inconscio p. 193). L’animatore interviene nel momento in cui lo ritiene opportuno, non necessariamente nel momento in cui gli viene richiesto. Quando se ne presenta l’occasione comunica al gruppo, nei limiti delle possibilità di comprensione dei partecipanti, ciò che ha compreso, o, con i suoi interventi, lo prepara gradualmente, lo aiuta ad intravedere ed a scoprire il senso dell’esperienza comune (cfr. ibidem, p. 48).
L’osservatore non interviene per tutta la durata della seduta. Naturalmente se gli accade di venire a conoscenza di un dato utile alla comprensione dell’esperienza del gruppo è importante che, al più presto, lo riferisca all’animatore. Il suo compito, tuttavia, si basa essenzialmente sull’ascolto e, al termine della seduta, sulla puntualizzazione dei punti a suo avviso nodali che tocca brevemente ”rovesciando ancora una volta il discorso manifesto e mettendo in questione le certezze raggiunte. Come un sasso che cade in uno specchio d’acqua scompiglia ancora una volta l’immagine di Narciso che rischia di prendere una forma definitiva, o, quanto meno, abbastanza stabile” (idem).
L’importanza del gioco psicodrammatico
Eugénie e Paul Lemoineutilizzarono come spunto per parlare dell’importanza del gioco psicodrammatico la descrizione fatta da Freud, in Al di là del principio del piacere, del gioco del fort-da, ‘inventato’ dal nipotino di Freud. Esso consisterebbe nel gioco di un bambino di un anno e mezzo che, gettando un rocchetto lontano per poi riprenderlo, elaborerebbe la frustrazione, il lutto dell’allontanamento dalla madre e realizzerebbe, così, un immaginario controllo su di essa. Il gioco del fort-da è la divertente scoperta che un oggetto ‘esiste’ anche quando è fuori del campo percettivo, e coincide con il momento di passaggio dal piano del reale al piano dell’immaginario.
Il gioco psicodrammatico ha in comune con il gioco descritto da Freud il fatto che entrambi si basano sulla rappresentazione, che esige la rinuncia alla soddisfazione immediata del desiderio. “Si verifica un cambiamento di meta per la libido: alla soddisfazione che si prova alla presenza dell’oggetto d’amore o quella che deriva dalla consumazione dell’oggetto stesso a livello orale, anale o genitale, si sostituisce una soddisfazione in qualche modo sublimata” (idem). Attraverso la presenza degli altri e dell’Altro (dimensione stessa dell’alterità) l’oggetto, che non può esistere realmente (piano della realtà), diventa la sua rappresentazione (piano dell’immaginario)che permette lo scambio.
Mentre per Moreno il carattere terapeutico dello psicodramma era dovuto alla catarsi, favorita dalla rappresentazione in situ, con l’avvento dello psicodramma analitico il punto cardine della terapia diventa la necessità di attuare al massimo la possibilità della “castrazione simbolica, che è alla base della nostra umanità” (ibidem,p. 47).
Secondo Lacan “la castrazione fa parte della problematica della mancanza che comprende: la privazione come mancanza dell’oggetto reale, la frustrazione come mancanza dell’oggetto immaginario e la castrazione come mancanza dell’oggetto simbolico” (Galimberti, Psicologia, p. 177). Lacan fa una distinzione tra il piano del reale, quello dell’immaginario e quello del simbolico. Per spiegare la differenza tra i primi due piani i Lemoine scrivono: “Per esempio, questo tavolo è là. … Anche se non ci fosse mai stato un tavolo, io potrei sempre immaginarlo … L’immaginario … consiste nel darsi un oggetto assente. Ciò premesso, non è il caso di discutere qui della realtà del tavolo in sé, né della realtà del mondo esterno, bensì solamente della relazione presenza-assenza dello stesso in rapporto a me” (Lemoine, Lo psicodramma, p. 9). Per i Lemoine lo psicodramma si colloca nel terreno dell’immaginario, non del reale, e permette di attivare anche la funzione simbolica. Continuano esponendo la differenza tra la funzione immaginaria e quella simbolica, sempre partendo dall’esempio del tavolo: “se questo è il tavolo al quale si riunisce per il pranzo tutta la famiglia, esso può diventare il simbolo del pranzo familiare, poi, passando da una metafora all’altra, della famiglia stessa, quindi di altre famiglie come la mia; entra in gioco a questo punto la funzione simbolica” (idem).Per i Lemoine l’elemento che permette questo passaggio dal punto di vista immaginario a quello simbolico è il gioco.
Esso si realizza nello spazio interno al circolo dei presenti, che deve essere il più neutro possibile. In esso le sedie possono fungere da oggetti come un letto, come una tavola, come un muro o un albero ed aiutare così i presenti ad immaginare la situazione che si vuole rappresentare. Elena Croce afferma che è meglio evitare di confondere la realtà con la rappresentazione che si svolge nel setting analitico, magari aggiungendo suppellettili che potrebbero dare una parvenza più realistica alla scena, ma che non farebbero altro che favorire la confusione tra il piano del reale ed il piano dell’immaginario.Anche l’ipotesi di far partecipare alle sedute persone che tra di loro hanno legami di parentela o di amicizia o di frequentazione è da evitare accuratamente. Nell’ottica di Moreno, che vedeva come fondamentale la funzione catartica dello psicodramma, una realizzazione in situ del racconto, nel luogo in cui era avvenuto realmente, e con le persone con le quali si era svolto, poteva raggiungere il massimo dell’intensità e dell’effetto terapeutico sugli attori. In una prospettiva analitica ciò perde valore, come anche il concetto di tele, mentre assume importanza, come vedremo, la nozione di transfert, essenziale nell’orientamento psicoanalitico freudiano (cfr. Croce, Il volo della farfalla,pp. 46-9).
Gli strumenti tecnici che caratterizzano il gioco psicodrammatico sono lo scambio dei ruoli, il doppiaggio, l’’a solo’. Quando l’animatore del gruppo propone ad uno dei partecipanti di giocare la scena di un sogno o di vita reale da lui narrata, come avveniva per lo psicodramma di Moreno, il protagonista sceglie gli io ausiliari che faranno le veci degli altri personaggi del racconto, mentre egli, nella prima parte del gioco, reciterà il suo ruolo. Nella seconda parte del gioco l’animatore deciderà lo scambio di ruolo tra il protagonista ed un io ausiliario, e la scena si ripeterà una seconda volta. Elena Croce ritiene che in questo modo sia possibile conoscere meglio le proiezioni nei confronti dell’altro e che ci si possa confrontare con la costellazione edipica imparando a fare i conti con la convinzione che qualcuno occupi una posizione di potere dalla quale siamo stati defraudati (cfr. ibidem, pp. 52-3).
Durante la realizzazione del gioco sia l’animatore sia gli altri partecipanti al gruppo che non rivestono i ruoli di protagonista o di io ausiliari possono decidere di intervenire, di doppiare uno dei personaggi della rappresentazione ponendoglisi alle spalle e parlando al suo posto. “Ciò conferisce spessore e capacità di incidenza al personaggio doppiato, rafforzandone la posizione o mettendola in crisi, in modo rassicurante o provocatorio o, addirittura, facendone scaturire elementi inattesi e aprendo interrogativi nelle aspettative più consolidate del protagonista” (ibidem,p. 53). Naturalmente l’intervento del terapeuta nel doppiaggio avrà una funzione diversa rispetto a quella degli altri partecipanti al gruppo, assumerà un significato analitico vero e proprio anche se, ribadisce la Croce, sempre salvaguardando al massimo la neutralità e l’astinenza teorizzate da Freud in riferimento alla funzione del terapeuta.
L’utilizzazione dell’’a solo’, che consiste in un monologo che in genere si colloca al termine di una sequenza di gioco, è a discrezione dell’analista che valuterà la necessità di trattenere il protagonista del gioco in una delle parti recitate nelle due rappresentazioni. “La struttura di questa risorsa tecnica può sembrare, in un certo modo, analoga a quella dell’epilogo in certe forme teatrali. Ma la sua funzione non è quella di concludere o di trovare un significato e, tanto meno, una morale a quanto si è svolto sulla scena; è piuttosto quella di ritardare il rientro del protagonista nello spazio del gruppo lasciandolo ancora qualche istante in uno spazio ‘intermedio’, in cui può parlare direttamente a se stesso … rinunciando a servirsi dei comportamenti gestuali … e uscendo fuori dalla rete relazionale che, nel gioco, ha appena finito di funzionare” (ibidem, pp. 53-4). Il discorso continua ad essere presente e diretto ed il posto occupato continua ad essere al centro del gruppo, ma il protagonista è da solo, cosa che può costituire un momento di maggior contatto con le parti più trascurate di se stesso, anche se l’inibizione spesso può portarlo a non dire neanche una parola.
Il transfert e le identificazioni
Moreno, come già è stato affermato, identificava con lo scopo dello psicodramma la catarsi emotiva, “la creazione di nuove situazioni e sensazioni, lo sviluppo di una matrice esistenziale ed emotiva nel gruppo, attraverso il télé, corrente incrociata di simpatia e comprensione” (Rosati in Yablonsky, Psico dramma, p. 9), chein termini freudiani perde il suo valore, mentre assumono importanza terapeutica i fenomeni del transfert e dell’identificazione.
Il concetto di transfert fu scoperto da Freud quando cominciò a rendersi conto che i suoi pazienti, nel corso della cura, manifestavano degli atteggiamenti molto particolari ed ambivalenti nei confronti dell’analista, che andavano dall’innamoramento, dall’idealizzazione o dall’identificazione, addirittura, all’aperta ostilità ed all’intolleranza. Si trattava di ‘riedizioni’ psichiche di situazioni che spesso si riferivano a all’infanzia o all’adolescenza, un particolare modo di ricordare e ripetere scene psichiche oramai dimenticate e rimosse. In seguito Lacan puntualizzerà che il transfert è la messa in atto della realtà dell’inconscio e che, quindi, non è rivolto alla persona dell’analista, ma alla funzione che egli svolge (cfr. Ricci, Sigmund Freud, pp. 66-7). Scrive Freud: “Il transfert diventa paragonabile alla zona di scambio fra il legno e la corteccia di un albero dalla quale deriva la formazione di nuovi tessuti e l’aumento dello spessore del tronco” (Freud in ibidem, p. 100). Una metafora davvero appropriata per descrivere come attraverso l’esperienza analitica si operi la trasformazione nell’individuo. Freud ritiene che senza il transfert, e quindi senza questa riedizione, riattualizzazione del rimosso non possa verificarsi una guarigione permanente (cfr. ibidem, p. 36). Si rende conto che il transfert scatta sul paziente proprio nel momento in cui stanno per essere svelati contenuti rimossi particolarmente importanti. Esso si rivela sotto forma di resistenza (resistenza di traslazione) e quindi può rappresentare un ostacolo, ma nello stesso tempo è uno strumento privilegiato per l’analista per accedere agli elementi del conflitto infantile nel momento in cui essi riaffiorano; la problematica del paziente, così, viene vissuta nel presente (cfr. Laplanche, Pontalis, Enciclopedia della psicoanalisi, pp. 647-8). In Al di là del principio del piacere (1920) Freud chiarisce che le riproduzioni del transfert “…si presentano con una fedeltà indesiderata, hanno sempre come oggetto una parte della vita sessuale infantile, ossia del complesso edipico e dei suoi esiti” (Freud in ibidem, p. 649). Freud andrà sempre più a convincersi che il transfert è una riattualizzazione del conflitto infantile.
Negli Studi sull’isteria Freud, a proposito del transfert, scrive: “…Questo nuovo sintomo, prodotto su modello antico – va trattato – al modo dei vecchi sintomi” (idem). Definisce, dunque, il fenomeno del transfert un sintomo. Per Lacan il sintomo è una ‘verità che resiste al sapere’. Se il soggetto accetta di attribuire al sintomo (significante) un significato che può essere trovato, e quindi si rende conto della propria mancanza e del proprio desiderio di colmarla, sarà stimolato e sostenuto da un’energia affettiva sufficiente a mantenere l’impegno nel lavoro analitico. Questo passaggio, per Lacan, è accompagnato dal desiderio per analista “che rende operante la svolta per cui il significante del transfert segna il tempo fondamentale in cui il sintomo diventa domanda” (Croce, Il volo della farfalla, p. 42). Il desiderio proiettato sull’analista, dato dalla mancanza, è in grado di “rimettere il lavoro analitico sulla strada inevitabilmente frustrante della ricerca della verità. È a questo punto che la cura prende il suo punto di partenza effettivo” (idem).
Ma cosa differenzia l’analisi individuale da quella di gruppo? Nel setting psicoanalitico classico freudiano l’analista è di spalle, mentre il paziente è disteso sul lettino solo con se stesso. Lo psicodramma, invece, offre più stimoli rispetto all’analisi individuale. In esso si realizza un gioco di sguardi, di mimica, di gestualità del tutto particolare. Il coinvolgimento, poi, non avviene soltanto con il terapeuta ma anche con gli altri pazienti, e quindi il fenomeno del transfert acquista un’altra dimensione: oltre al transfert verticale nei confronti del terapeuta si verificano anche transfert orizzontali nei confronti degli altri membri del gruppo (ibidem, p. 61).
I Lemoine scrivono che nello psicodramma ciascun membro del gruppo può orientare il transfert sui terapeuti, sul gruppo in quanto tale, o su uno dei componenti di esso. La funzione del transfert è fondamentale, ma la forza motrice della vita di gruppo è l’identificazione. “Lo psicodramma è la sede delle identificazioni” (Lemoine, Lo psicodramma, p. 55). L’identificazione viene definita come “ciò che ci consente di riconoscerci nell’altro” (ibidem, p. 59). Presuppone la presenza di due entità distinte, un modello e ciò nel quale esso si riconosce. Si attua attraverso il sentimento dell’amore ed il desiderio dell’altro e, se non lo può avere, cerca di esserlo: l’alternativa dell’amore che si muove tra l’avere o l’essere (cfr. idem).
I Lemoine
esemplificano la situazione teorizzata portando l’esempio pratico di Jeanne che
si trova ad affrontare, in un gioco, la scena di un suo sogno in cui lei invita
vicino a sé un ragazzo ‘infelice’, per terra, su una spiaggia. La scena viene
ripetuta, a distanza di tempo, in diverse sedute, con variabili differenti. È
importante far presente che Jeanne riesce ad identificarsi sia con il suo
personaggio sia, al cambio dei ruoli, con il ragazzo infelice. Nel suo ruolo lo
culla come una madre, esprimendo il desiderio latente di essere cullato da sua
madre. Nello scambio delle parti, poi,
il soggetto improvvisamente si rianima poiché ritrova nell’altro personaggio il
suo vero desiderio. “lo scambio delle parti è infatti un’identificazione
terapeutica che invita il soggetto a ripercorrere in senso contrario il cammino
di una propria identificazione. Inevitabilmente egli interpreta meglio la parte
dell’altro. Il motivo c’è. È lui stesso. Proiettando il suo desiderio
all’esterno, sull’altro, aveva cancellato se stesso, ma così facendo aveva
anche soppresso l’altro” (ibidem, p. 63). Jeanne, infatti, aveva proiettato
il suo desiderio sull’altro e,dando il suo affetto al ragazzo
rispondeva alla domanda dell’altro secondo ciò che lei credeva desiderasse
l’altro con il quale si era identificata. Ma lei, in quel modo, si era
identificata con se stessa e con il suo bisogno di essere aiutata. Appare
chiaro come questo tipo di identificazione, se non viene risolta, chiude il
soggetto nell’identico invece di portarlo verso l’altro.
LO PSICODRAMMA COME TEATRO DI IMMAGINI
Tutto questo non è mai accaduto,
ma è così da sempre (Sallustio).
Chiamate, vi prego, il mondo ‘la valle del fare anima’.
Allora scoprirete a che serve il mondo (Keats).
Quando l’uomo cade nel corpo non perde la divinità della sua mente
e può recuperare la sua piena natura divina … attraverso l’esperienza religiosa ermetica,
in cui la luce e la vita divina, che alberga nella sua stessa mente, gli si rivelano (Yates).
La psiche come ‘gruppo’ di immagini
Plotino scriveva: “L’uomo è molti”. La psicologia archetipica riprende la saggezza degli antichi ed afferma con Plotino che dentro di noi abita una molteplicità di persone psichiche che influenzano i pensieri, le fantasie, le azioni di ogni giorno. Questa molteplicità di persone, che sono le nostre immagini, tessono la trama immaginaria della nostra vita psichica, della quale l’io non è altro che uno degli attori.
La denominazione di psicologia archetipica risale allo psicologo psicoterapeuta americano James Hillman, ma il padre spirituale è Carl Gustav Jung, il fondatore della psicologia analitica. È Jung ad utilizzare la parola archetipo per la prima volta nel 1919 in Istinto e inconscio, mentre in precedenza aveva usato, per indicare la medesima realtà, il termine immagine arcaica (Urbild), che riprese da Jacob Burckhardt. Egli definisce gli archetipi come le immagini dell’istinto. Scrive: “l’istinto non è soltanto una spinta verso l’esterno, partecipa anche alla rappresentazione delle forme. L’animale, per esempio, ha una certa immagine delle piante tant’è vero che le riconosce. I nostri istinti non si esprimono soltanto nelle nostre azioni e reazioni, ma anche nel modo in cui ci rappresentiamo ciò che immaginiamo. L’istinto non è solo biologico, ma anche, si potrebbe dire, spirituale. E ripropone sempre certe forme, che si possono studiare risalendo fino alle ere più remote presso tutti i popoli. Queste forme sono gli archetipi” (Jung in McGuire, Hull – a cura -, Jung parla, interviste e incontri,pp. 509-10). Essi ci ripropongono ogni notte immagini mitologiche, alchemiche che appartengono alla storia dell’umanità, a quello che Jung chiama inconscio collettivo.
Jung racconta di essersi accorto della presenza di questo piccolo popolo dentro di noi quando fu assalito da una crisi profonda, nel 1914. Egli fu ammonito, in sogno, dall’immagine di un poeta comico greco, vissuto tra il IV ed il III secolo a. C., di nome Filemone. Filemone lo esortava a dare spazio alle immagini della psiche in quanto personificazioni della realtà dell’anima (psyché in greco vuol dire ‘anima’). Cercava di fargli comprendere che i pensieri, le fantasie che lo assalivano non erano sue, non sono nostre più degli animali in una foresta, degli uccelli che volano nell’aria, di uomini in una stanza. Il fatto di vederli non vuol dire che siamo stati noi a produrli, che ne siamo responsabili. Scrive: “Egli un po’ alla volta mi insegnò l’obiettività psichica, la ‘realtà dell’anima’” (Jung in Jaffè – a cura -, Ricordi sogni riflessioni di C. G. Jung, p. 226).
La nostra psiche è formata da una molteplicità, da un gruppo di persone psichiche che sono le immagini. Lo vediamo chiaramente attraverso il sogno (dal greco oneiros, che significa ‘immagine’) nel quale compaiono in maniera più esplicita.
Già da Freud il sogno era considerato come un’insieme di rappresentanze pulsionali.Freud, lo precisò Lacan, non parlò mai di istinto, più vicino alla sfera biologica, ma di pulsioni. “Per Freud la pulsione si trova al limite tra il somatico e lo psichico, è cioè al di qua dell’opposizione tra conscio e inconscio; da un lato, essa non può mai diventare oggetto della coscienza e, dall’altro lato, essaè presente nell’inconscio solo tramite le sue ‘rappresentanze’ costituite essenzialmente da ‘rappresentazioni’” (Perilli, Corpo Mente – Da Freud a Jung, p. 131). “Le rappresentanze inconsce sono organizzate in fantasie, trame immaginarie, a cui si fissa la pulsione e che possono essere concepite come vere messe in scena del desiderio” (Laplanche, Lontalis, Enciclopedia della psicoanalisi, p. 248).
Nel gruppo dei componenti dello psicodramma, come nel gruppo dei personaggi del sogno, avviene la stessa messa in scena delle fantasie, delle trame immaginarie, del desiderio di cui parla Freud. Anzieu, lo abbiamo visto, paragona il gruppo al sogno ed afferma che anche il gruppo, come il sogno, è un immediato soddisfacimento di un desiderio di una pulsione. Afferma che i soggetti vanno ai gruppi nella stessa maniera in cui durante il sonno entrano in un sogno. Non vede differenza tra gruppo e sogno per quanto riguarda la dinamica psichica. Quindi la dinamica psichica di un individuo può essere paragonata alla dinamica psichica di un gruppo di individui. Sembra doveroso, a questo punto, citare Elena Croce secondo la quale “l’individuo … può essere considerato come un ‘gruppo’ (o un insieme di gruppi) più o meno integrato di personaggi e di istanze” (Croce, Il volo della farfalla,p. 74). Quindi l’idea della molteplicità non la troviamo soltanto nella psicologia analitica o nella psicologia archetipica, ma anche nelle teorie che da Freud si dispiegano.
Freud in una famosa frase, tuttavia, scrive: ‘Wo es war, soll Ich werden…’. Frase che solitamente si traduce così: ‘Dove era l’Es deve subentrare l’Io…’. Per Freud l’Io deve prendere coscienza delle realtà inconsce. È ‘un’opera di civiltà’, continua la frase citata. È un’opera di civiltà agli occhi dell’Io dell’agire diurno nei confronti delle pulsioni e dei desideri inconsci, che per Freud lo rendono malato.
Se, invece, si fa il salto verso le immagini, ci si potrà rendere conto del fatto che anche l’io è un’immagine come le altre, un’anima, come dice Hillman, che si trova a vivere in un pandemonio di immagini, in un palcoscenico interiore, in cui ogni immagine si presenta autonomamente rispetto alle altre, all’io ed alla realtà esterna. D’altronde era questo che Filemone, l’immagine che comparve a Jung nel 1914, voleva comunicare, l’autonomia dell’anima, che oltretutto è l’unica realtà che ci è data di conoscere. Per Jung ogni esperienza che abbiamo, “ogni pensiero, ogni sentimento e ogni percezione sono composti d’immagini psichiche, e il mondo esiste soltanto in quanto noi siamo capaci di produrre un’immagine” (Jung, Commento al “Libro della grande liberazione”, in Opere, 11, p. 494). Anche il nostro corpo, che nello psicodramma ha parte attiva, esiste per noi in quanto gli attribuiamo un’immagine. È stato questo il passaggio che ha permesso a Jung di risolvere il dualismo tra il biologico e lo psichico. Attraverso le immagini il biologico si fa psichico: l’istinto intuisce se stesso e si fa psiche (cfr. Perilli, Corpo Mente – Da Freud a Jung). Scrive Jung: “L’essere psichico è, in verità, l’unica categoria dell’essere di cui abbiamo conoscenza diretta, poiché nulla può essere conosciuto se non appare come immagine psichica. Se il mondo non assume la forma di un’immagine psichica, è praticamente non esistente” (Jung in Hillman, L’anima del mondo e il pensiero del cuore, p. 24).
Basti pensare alle emozioni, che noi percepiamo tramite il corpo. Se non vengono accolte si manifestano attraverso il sintomo prendendo il sopravvento senza che ce ne sia consapevolezza. Se invece trovano accoglimento possono trasformarsi in immagine e quindi essere espresse anche tramite la parola. Nello psicodramma può avvenire questo passaggio poiché le emozioni possono trasformarsi in immagine attraverso la rappresentazione aprendo la via a riflessioni più consapevoli.
Hillman pone la necessità di dare vita alle immagini della nostra psiche, ci insegna ad averne cura affinché possiamo condividere con esse la ricchezza e la bellezza delle quali sono portatrici. Ci esorta ad ascoltare il logos della psiche, il discorso dell’anima. L’anima parla attraverso le storie, i sogni, le fantasie, le immagini che abitano dentro di noi ma che non sono nostre e che, anche se non ce ne accorgiamo, dirigono i nostri punti di vista, le nostre idee,le nostre azioni, i nostri comportamenti.
L’individuazione e lo psicodramma
Una grande differenza tra la psicoanalisi di Freud e la psicologia analitica di Jung consiste nel fatto che Freud va alla ricerca delle cause di un evento psichico, mentre Jung non si occupa tanto delle sue premesse storiche, ma dello scopo al quale esso tende (cfr. Jung, La funzione trascendente, in Opere, 8, p. 89; Jung, L’essenza dei sogni, in Opere, 8, p. 303). Anche Hillman evidenzia come i due psicologi abbiano un modo diverso di concepire la psicologia. Freud rimane ancorato, nei racconti dei suoi casi clinici, a schemi causali strettamente legati alle fasi storiche della vita dei pazienti, la sua è una analisi eziologia, e quindi la domanda che si pone è ‘perché?’. “Jung ci insegna a considerare il fine cui tendono i personaggi e il luogo ove si dirigono, perché sono questi aspetti che principalmente influenzano la forma delle storie” (Hillman, Le storie che curano, p. 11). La domanda che si pone, quindi, è ‘a che scopo?’.
Per Jung le storie individuali si dispiegano attraverso un processo che egli definisce processo di individuazione. Racconta di essersi accorto della sua esistenza osservando l’evolversi delle immagini psichiche in lunghe serie di sogni. Esse gli si presentavano non come eventi incoerenti ed unici, ma secondo un processo che si sviluppa per gradi programmati (cfr. Jung, L’essenza dei sogni, in Opere, 8, p. 312). “Questo processo in verità corrisponde al naturale decorso di una vita nella quale l’individuo diventi quello che da sempre era” (Jung, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, in Opere, 9*, p. 38). Lo scopo è raggiungimento del Sé che è allo stesso tempo il centro della psiche e la sua totalità, la meta del processo di individuazione e anche l’origine di esso, come dice Aurigemma il nulla pieno di possibilità infinite (cfr. Aurigemma, Prospettive junghiane, p. 202).
Il processo di individuazione è inteso da Jung come un percorso che si svolge individualmente. Egli afferma, parlando di gruppi e masse, che nel gruppo si corre il rischio di arenarsi a livello collettivo(cfr. Jung, Sul rinascere, p. 124) poiché ogni esperienza di gruppo determina nell’individuo un livello di consapevolezza inferiore rispetto a quello che invece caratterizza l’esperienza individuale. Parla del gruppo in maniera positiva per quanto riguarda le rappresentazioni solenni di cerimonie sacre. In esse la moltitudine dei fedeli può mantenere una certa consapevolezza rimanendo cosciente di ciò che si sta verificando senza sconfinare nell’istintualità inconscia. Ciò avviene perché sono stimolati l’interesse e l’attenzione del singolo che può vivere così un’esperienza relativamente individuale (cfr. ibidem, pp. 123-4).
Gasseau tuttavia cita un articolo di Jung, apparso sulla rivista Spring, sull’importanza dell’imitazione in ambito sociale (cfr. Gasseau, Gasca, 1991, Lo psicodramma junghano, Boringhieri, Torino p. 20) ed una lettera scritta il 26 Gennaio 1955 ad Hans Illingcherecita così:
“(…) Io stesso, una quarantina d’anni fa, ho fondato un gruppo [Il Circolo psicologico di Zurigo la cui fondazione avvenne nel 1916]; …era composto da persone ‘analizzate’, … (e il suo scopo era quello) di costellare l’atteggiamento sociale dell’individuo. Esso è attivo ancora oggi. L’atteggiamento sociale, infatti, non entra in funzione nel rapporto dialettico tra paziente e medico, e quindi può mantenersi in una situazione di disadattamento, cosa che accadeva alla maggior parte dei miei pazienti. Questo stato di malessere compariva solo al momento della formazione del gruppo e rendeva necessario un riequilibrio reciproco” (Jung c. g., 1946/55, Lettere II, MaGi, Roma, 2006, pp. 394-5; cfr. ibidem,pp. 21-2,)
Per riassumere Jung raggiunge “…le seguenti conclusioni:
- La terapia di gruppo è indispensabile per l’educazione dell’uomo sociale.
- Essa però non sostituisce l’analisi individuale.
- Le due forme di psicoterapia si completano a vicenda.
- Il rischio della terapia di gruppo è quello di restare fermi su un piano collettivo.
- Il rischio dell’analisi individuale è quello di trascurare l’adattamento sociale”.
(ibidem, p. 396; cfr. idem).
Dunque, secondo questo scritto, Jung non escluderebbe completamente la possibilità che il gruppo possa essere terapeutico. E non sbagliava nel ritenere che il gruppo possa essere di ostacolo al processo di individuazione del singolo individuo, ma l’esperienza ha insegnato che molto dipende da come esso viene gestito. L’interazione con i membri dello psicodramma può rappresentare, infatti, attraverso i contributi personali, le immagini che vengono messe in comune, un terreno fertile alla realizzazione del processo di individuazione della psiche. Scrive Rosati: “…se lo psicologo analista mantenesse un’ottica coerentemente junghiana interpretando il senso di uno psicodramma attraverso un ricorso sistematico alla teoria degli archetipi, egli finirebbe per omologare le storie e i destini dei partecipanti sotto il segno di comuni costellazioni dell’inconscio collettivo, perdendo di vista le occasioni di differenziazione individuale offerte alle concrete esperienze di gruppo” (Rosati, L’attivazione dell’immagine nello psicodramma junghiano, p. 579). Nello psicodramma il ruolo dell’animatore è fondamentale proprio perché attraverso i suoi interventi si può attuare la differenziazione tra le singole individualità del gruppo.
Migliorati, anch’egli psicoterapeuta di gruppo di orientamento junghiano, afferma che«il gruppo funziona come una metafora esperienziale della psiche complessa … Ogni membro del gruppo rappresenta per gli altri, a seguito dei noti meccanismi (identificazione proiettiva, introiezione ecc.), un aspetto della loro complessità; e viceversa, il gruppo nel suo insieme individua una dinamica affettiva unitaria a cui ciascuno partecipa» (Migliorati, 1989, p. 48). L’autore ritiene che il processo di individuazione possa essere favorito dalle relazioni del gruppo poiché, come teorizza la Gestalt, la percezione è il risultato dell’interazione e dell’organizzazione delle varie parti, non la semplice somma di esse. Dunque esiste una dinamica unitaria anche nello psicodramma della quale ogni membro fa parte, un processo di individuazione analogo a quello della psiche individuale, ma che riguarda il gruppo.
Partendo dalle argomentazioni di Jung e tenendo presente le riflessioni degli psicodrammatisti junghiani si può dunque affermare che lo psicodramma è il luogo in cui si può realizzare un processo di individuazione del gruppo che tende ad un Sé di gruppo ed un processo di individuazione della psiche individuale dei singoli componenti, che tende ad un Sé individuale. Va sottolineato in tal senso che Jung stesso concepiva l’individuazione come differenziazione delle parti della psiche individuale, concetto che si potrebbe estendere alla differenziazione tra i soggetti nello psicodramma.
Dall’analisi empirica dei sogni risultano valide sia l’impostazione che pone l’accento sul processo di individuazione come ricerca dell’armonia, dell’unità, sia di quella che lo definisce come differenziazione. Come un sogno, lo psicodramma può essere analizzato secondo entrambe le chiavi di lettura. In esso si svolgono le trame delle immagini nella psiche dei singoli individui, realizzando il Sé della psiche. Come in un sogno di gruppo poi le immagini individuali, entrano in relazione con le immagini degli altri componenti del gruppo, insieme si muovono in un processo di individuazione che realizza un Sé di gruppo. È come nel pantheon olimpico in cui le divinità, nella sacralità di ognuna, realizzano la sacralità dell’intero Olimpo.
Lo psicodramma, luogo del fare anima
Da quanto è stato detto appare chiaro che nello psicodramma junghiano il gruppo esiste, ed esiste nella sua individualità e nella sua molteplicità. Lo psicodramma diventa il luogo in cui le vere attrici sono le immagini, in cui l’immagine non è più qualcosa che si vede, ma un modo di vedere (Casey), un vedere del cuore (Corbin). Ed allora si può avere accesso a quella che Hillman ha definito, prendendo in prestito l’espressione da John Keats, la valle del fare anima. Fare anima “è essenzialmente un’attività immaginativa” (hillman, Il mito dell’analisi, p. 20), l’attività fondamentale della psiche, che ne caratterizza la vera essenza. Il logos dell’anima ha uno stile immagistico, è un racconto di natura metaforica. E la metafora è lo strumento del fare anima.
Hillman scrive che Jung, parlando degli archetipi ed insistendo sulla loro indefinibilità, sembra che parli proprio di metafore. Le metafore, per l’appunto, sono quelle figure retoriche “non … passibili di traduzione interpretativa, senza che ne vada distrutta la peculiare unità” (hillman, Le storie che curano, pp. 45-6). Leopardi, nel Canto notturno di un pastore errante dall’Asia, rivolgendosi alla luna scriveva: “…tu, solinga eterna peregrina…”. Il verso assume tutto un altro aspetto attribuendogli una spiegazione: il pellegrino e la luna hanno in comune la caratteristica di viaggiare, l’uno per le strade e l’altra per il cielo. Il poeta ha usato una metafora che immediatamente permette al lettore di intuire cosa egli volesse esprimere. Accade allo stesso modo per le immagini della psiche poiché esistono in noi quei modelli di funzionamento psichico (cfr. hillman, Re-visione della psicologia, p. 19), gli archetipi, che ci permettono di intuire la doppia valenza del discorso dell’anima.
Mentre per Freud il sogno era allegorico, cioè la descrizione narrativa di un argomento al posto di un altro, per Jung il sogno è un simbolo, “un far coincidere in un’unica voce due dissonanze” (ibidem, p. 45). L’analisi trasformerebbe il simbolo in segno privandolo della sua indefinibilità e della sua ricchezza creativa.
Jung affermava che gli archetipi contengono in sé germi di possibilità incalcolabili. Ed il lavoro sugli archetipi è sempre un lavoro di amplificazione delle immagini. Nell’amplificazione in realtà ciò che si fa è “mettere a confronto eventi psichici singoli con fenomeni collettivi chiaramente affini” (Jung, Riflessioni teoriche sull’essenza della psiche, in Opere, 8, p. 244). Ed è l’archetipo la metafora attraverso cui i singoli eventi psichici del sogno rievocano i miti della collettività.
Hillman non fa distinzione tra le immagini. Ogni immagine, anche se ha un significato specifico per un determinato individuo, è sempre metaforica, è sempre archetipica, riguarda sempre la collettività degli individui, l’Anima Mundi. Riprende questa concezione da Jung che aveva affermato: “L’interpretazione di un sogno profondo … non può mai limitarsi alla sfera personale. Il sogno contiene un’immagine archetipica, il che denota sempre che la situazione psichica del sognatore si protende oltre lo stato puramente personale dell’inconscio. Il suo problema non è più soltanto personale, ma riguarda l’umanità in generale. (…) La capacità di applicare un punto di vista generale ha grande importanza terapeutica. La terapia moderna non ne tiene gran conto, mentre la medicina antica sapeva bene che innalzare la malattia personale ad un livello superiore più impersonale aveva un effetto curativo” (Jung, Fondamenti della psicologia analitica, in Opere, 15, p. 113).
Per Hillman ogni immagine è un’anima e l’individuo è soltanto attraversato da essa. Scrive che, “Sebbene ogni immagine vada considerata come un evento individualizzato e unico, come ‘quell’immagine e nessun’altra’, un’immagine archetipica è universale perché ha una risonanza collettiva, transempirica” (Hillman, Psicologia archetipica, p. 815). Lo psicodramma allora diviene il luogo privilegiato del fare anima. In esso è prevista la presenza di una pluralità di partecipanti, e quindi di una situazione collettiva in cui ognuno è portatore di una molteplicità, di una ricchezza interiore di immagini. Queste immagini, nella loro interazione, rianimano le trame collettive riproponendo, rimemorando, i tratti immaginali, i miti che hanno caratterizzato la storia dell’umanità.
Scrive Hillman: “Attraverso l’immaginazione l’uomo ha accesso agli Dei: attraverso la memoria gli Dei entrano nella nostra vita” (Hillman, Il mito dell’analisi, p.187), intendendo per Dei il piccolo popolo che abita dentro di noi,la molteplicità delle nostre immagini.
Il dramma della psiche
Hillman scrive che “Ogni manifestazione del comportamento umano, oltre al suo contenuto palese e letterale, ne ha sempre uno psicologico” (hillman, Psicologia archetipica, p. 817). Riprende Jung ed afferma che egli quando utilizza il termine immagine non si riferisce al riflesso di un oggetto o ad una percezione, ma alla realtà dell’anima, che si esprime con un linguaggio poetico. La parola immagine deriva non a caso dall’uso poetico, e con essa si intendeuna figura di fantasia, un’immagine fantastica (cfr. Hillman, Saggi sul puer, pp. 87-8).
La psiche si esprime attraverso un suo logos, il discorso dell’anima, un discorso antico come l’uomo, un discorso archetipico che si dispiega in forma poetica attraverso storie, miti, leggende, tradizioni, ritualità che chiedono di vivere dentro di noi. Hillman riprende da Jung la concezione secondo la quale il sogno ha una struttura drammatica e scrive: “L’addentrarsi nel dramma fu un’altra delle mosse letterarie di Jung; fu un altro passo cruciale, che avvicina la psicologia alla poetica. E voglio aggiungere questo pensiero come ipotesi, e in corsivo per sconcertarvi: se il sogno è natura psichica per sé, incondizionata, spontanea, primaria, e se questa natura psichica può mostrare una struttura drammatica, allora la natura della mente è poetica. Per andare alla radice dell’ontologia umana, alla sua verità, alla sua essenza e natura, ci si deve allora muovere nello stile narrativo e si devono usare strumenti poetici. Per capire la struttura del sogno ci volgiamo al dramma; la poiesis è la via regia alla via regia. L’inconscio produce drammi, invenzioni poetiche: è teatro” (Hillman, Le storie che curano, p. 47).
Jung in L’essenza dei sogni scrive che nella maggior parte dei sogni si può riconoscere una certa struttura non diversa da quella del ‘dramma’. Identifica in essa quattro fasi.La prima, che definisce col nome di esposizione, indica il luogo dell’azione (le indicazioni temporali sono più rare), le persone agenti e spesso la situazione iniziale. La seconda è quella dello sviluppo della trama, in cui l’azione si complica, subentra una certa tensione nell’attesa che accada qualcosa. Nel culmine o ‘peripezia’ del dramma accade qualcosa di decisivo, per poi concludere con la lysis, la ‘soluzione’, che è il risultato prodotto dal lavoro onirico e che può consistere il una indicazione o in una conclusione.
Hillman, anche se non condivide la distinzione che Jung attribuisce alle varie fasi del sogno, una distinzione molto letterale, riprende l’intuizione di Jung a proposito della struttura drammatica del sogno e della psiche stessa e, riferendosi ad una nota espressione di Freud secondo il quale il sogno è la via regia per accedere all’inconscio, definisce la poiesis come la via regia alla via regia, la via regia per accedere al sogno, e quindi alle immagini psichiche. Potremmo allora definire lo psicodramma, il luogo in cui si mettono in comune e si intersecano storie, sogni, immagini della psiche in forma drammatica, un’ulteriore via regia per entrare in contatto con la realtà dell’anima.
Va chiarito che Hillman, pur privilegiando l’aspetto artistico della psicoterapia, che comunque è fondamentale, non esclude la sua capacità di guarire. Egli scrive nella sua opera che si intitola proprio Le storie che curano: “La mente è fondata nella sua stessa attività narrativa, nel suo fare fantasia. Questo ‘fare’ è poiesis. Conoscere la profondità della mente significa conoscere le sue immagini, leggere le immagini, ascoltare le storie con una attenzione poetica, che colga in un singolo atto intuitivo le due nature degli eventi psichici, quella terapeutica e quella estetica” (ibidem, p. III). Ma, continua, “La capacità della psicoterapia di guarire, dipende dalla sua capacità di continuare a ri-raccontarsi, in rinnovate letture immaginative delle sue stesse storie” (ibidem, p. V). Dando ai sogni, alle storie, alle fantasie, sia in analisi individuale sia in quella di gruppo, un luogo per esistere, ci si occupa di loro, si ha cura (che non prescinde il curare) delle immagini dentro di noi che si liberano in nuove, ma sempre antiche, immagini, fantasie, storie.
La figura dell’animatore
Come ho già precisato, la figura dell’animatore ha un ruolo fondamentale nella dinamica dello psicodramma. Può essere dipinto attraverso l’immagine dell’auriga della biga alata platonica che deve saper gestire le energie dell’anima, il cavallo bianco ed il cavallo nero, in modo da non farsi travolgere dall’uno o dall’altro. Potrebbe prevalere il cavallo nero “storto, eccessivo, conformato senza regola; presenta la cervice massiccia, il collo breve; i lineamenti schiacciati, la tinta oscura, l’occhio scintillante iniettato di sangue; si accompagna a violenza e a millanteria; è peloso intorno alle orecchie, sordo e a stento cede alla frusta coi pongoli” (Platone, Fedro (a), 253e). In questo caso il gruppo segue l’onda delle passioni abbandonandosi ad esse ed il rischio è quello di cui parlava Jung, di arenarsi a livello collettivo, di rimanere inflazionati dalle immagini collettive che si attivano senza il controllo di uno sguardo esperto che le possa indirizzare. Anzieu descrive questa situazione con la metafora dell’oceano (cfr. cap. 2 di questo lavoro). Con Jung potremmo parlare di Uroboros materno nel quale si rischia di annegare, di non esistere, ma che allo stesso tempo dà calore e sicurezza, la sicurezza del non mettersi in gioco in prima persona, che si sgretola invece quando cominciano a nascere le singole individualità.
Questa situazione di caos originario uroborico si presenta in modo evidente nei gruppi agli inizi. È emersa ad esempio in gruppi composti da intellettuali che, per non mettersi in gioco in prima persona, si dilettano in dissertazioni storico-scientifico-culturali, oppure in gruppi di giovani, per i quali il problema pregnante è quello del rapporto con l’altro sesso, che si smarriscono in generalizzazioni su come sono gli uomini o le donne perdendo di vista le storie personali.
In questi casi il ruolo dell’animatore è fondamentale. Dal caos iniziale, dall’uroboros si deve cominciare a differenziare. Egli è l’alchimista che conosce quali sono le fasi del processo che conduce all’unità: solve et coagula. Allora entra in funzione il cavallo bianco della biga alata platonica: “quello in miglior forma, è di figura dritta e snella, ha la cervice alta, le froge regali, il mantello bianco e gli occhi neri, ama la gloria temperata e pudica, ed è amico dell’opinione verace; lo si guida senza frusta solo con l’incitamento e la ragione” (Platone, Fedro (b), 253d-e).
Ma come per il cavallo nero, se prende il sopravvento il cavallo bianco, l’energia razionale, lo psicodramma cessa di essere il luogo in cui si dà vita alle immagini, il luogo del fare anima e diventa luogo di letteralismi. Le stesse idee di processo dinamico, individuazione, inconscio collettivo, risultano sterili letteralismi se non si adotta quella che Hillman definisce una visione in trasparenza, se non si abbandona l’idea stessa come nozione per vedere attraverso essa. Egli utilizza la metafora del vetro per rappresentare la realtà psichica. Il vetro non è visibile poiché assume l’aspetto del suo stesso contenuto e se i contenuti psichici sono posti dietro ad un vetro vuol dire che sono nate le immagini, che è avvenuto il passaggio dalla realtà palpabile alla realtà metaforica. “Soltanto quando l’alchimista riusciva a mettere le sue sostanze d’anima in un vaso di vetro e a tenervele, aveva effettivamente inizio il suo lavoro psicologico. Il vetro è l’immagine concreta della visione in trasparenza” (Hillman, Re-visione della psicologia, p. 247).
Vedere in trasparenza vuol dire accogliere le immagini dentro di noi per poter com-prendere l’altro, com-patire l’altro, e vedere con gli occhi dell’anima, attraverso essi, le storie, i racconti dell’anima.
La figura dell’osservatore
Se lo psicodramma è il luogo in cui le immagini possono trovare vita e se le immagini sono il prodotto della fantasia allora ha ragione Elena Croce nel dire che in esso non hanno dimora la certezza, la stabilità poiché altrimenti, aggiungo io, si rischia di ingabbiare e di uccidere ancora una volta la ricchezza creativa delle immagini nella logica dell’io, si rischia il sacrificio dell’indomito cavallo nero sull’altare dell’equilibrio e della staticità. L’osservatore quindi, ripercorrendo e mettendo in evidenza i punti fondamentali della seduta, tenderà a rovesciare o a mettere in dubbio le certezze raggiunte evocando nuovi punti di vista anch’essi possibili. Con parole ed espressioni come ‘forse…’, ‘non potrebbe essere che…’ riprende tematiche lasciate in sospeso dall’animatore aprendo il discorso immagistico a nuove possibilità, a storie sempre nuove. La Croce, che ha alle spalle una grande esperienza analitica come psicoanalista sia individuale sia di gruppo, una volta disse che comunque è sempre bene accennare, insinuare il dubbio, esprimere i propri pensieri al paziente poiché noi non sappiamo cosa egli farà delle nostre parole, ma sicuramente qualcosa ne farà (cfr. croce, comunicazione personale). Nel consulto delfico della Pizia la sacerdotessa non taceva, non diceva, accennava. Le parole dell’osservatore, come quelle della sacerdotessa, risuonano nella psiche dei partecipanti. Per questo è importante che siano puntuali ma ad ampio raggio, che l’osservatore non imponga le proprie certezze ma che suggerisca, che evochiper lasciare alle immagini psichiche la possibilità di creare altre immagini, di fare poiesis, di fare anima.
Fare anima vuol dire fare immagini che rappresentano la realtà della psiche individuale e collettiva, immagini che vengono da lontano, immagini archetipiche. L’osservatore allora, seguendo l’insegnamento di Jung, può soffermarsi brevemente anche nell’amplificazione evocando altre immagini ereditate dalle fantasie umane collettive, dal mito, dall’alchimia, dalle fiabe e dalle tradizioni popolari.
Scrive Jung: “Quando deve trattare con un archetipo, un analista farà bene a riflettere. Nel trattare con l’inconscio personale non si deve pensare troppo e nemmeno aggiungere qualcosa alle associazioni del paziente. È forse possibile aggiungere qualcosa alla personalità di un altro? … L’altro ha una propria vita e una propria psiche, perché è una persona. Ma quando non è una persona, quando è anche me stesso, ha la mia stessa struttura psichica di fondo, io posso cominciare a pensare, ad associare per lui. Posso addirittura fornirgli il contesto necessario perché lui non lo avrà senz’altro, non sa da dove provenga il granchiosauro e non ha alcuna idea di cosa significhi, mentre io lo so e posso dargli il materiale di cui ha bisogno” (Jung, Fondamenti della psicologia analitica, 15, pp. 101-2).
L’amplificazione quindi diventa un’altra chiave di lettura delle storie, quella più antica e più vera, nella quale le immagini si liberano dai legami con la realtà concreta ed individuale sfociando nella loro matrice collettiva, “Facendo confluire il cosmico nel personale e liberando il personale nel cosmico, il metodo diventa una re-ligio, un ri-collegare, un ri-memorare” (Hillman, Animali del sogno, p. 24) e lo psicodramma diviene così il teatro della memoria.
Hillman scrive che l’anima immaginativa “Noi la incontriamo nelle sue numerose incarnazioni come anima delle acque senza le quali inaridiremmo, come anima della vegetazione che inverdisce la nostra speranza … come Signora degli Animali che cavalca le nostre passioni. Essa è … un’unghiuta arpia, un freddo e bianco spettro dalle insane manie – ma in pari tempo una nutrice, un’ancella, una ninfetta Cenerentola, incerta e priva di storia, una tabula rasa in attesa della parola. Ed è anche la Sofia della sapienza, la Maria della compassione, la Persefone della distruzione, l’irresistibile Necessità e Moira e la sua Musa” (Hillman, Re-visione della psicologia, pp. 94-95). Ed è a queste immagini che si vuole dare nuova vita, nei luoghi in cui diamo a loro la possibilità di esprimersi ed a noi di ricordare, rimemorare. Uno di questi luoghi della memoria è lo psicodramma.
Il momento del gioco
Il gioco, scrive Elena Croce, è “l’elemento centrale e qualificante” (Croce, Il volo della farfalla,p. 46) dello psicodramma, anche se si può verificare che in alcune sedute non si realizzi. Nello psicodramma analitico s’impone la necessità, continua la psicoterapeuta, di passare dal discorso indiretto del racconto, fatto al posto, al discorso diretto, che si realizza nel gioco psicodrammatico.
Il gioco è come il sogno, un sogno dormito in piedi (Jean Cocteau). In esso “il sognatore è invitato a recitare il suo sogno come se fosse una commedia ma anche a ristrutturarlo dandogli il finale e l’esito simbolico da lui immaginati” (Rosati, L’attivazione dell’immagine nello psicodramma junghiano, p. 589). È il luogo in cui la fantasia e le immagini interiori hanno la possibilità di esprimersi liberamente, come avviene nel gioco spontaneo dei bambini. Il dramma interiore di ogni partecipante al gruppo così si trasforma in un gesto teatrale. Non a caso drama in inglese significa teatro e to play vuol dire giocare ma anche recitare. Winnicott affermava che forse soltanto nel gioco sia fanciulli sia adulti sono veramente liberi di esprimere la propria creatività, la libertà che nello psicodramma di Moreno prende il nome di spontaneità, il mezzo per esprimere in maniera autentica la propria realtà psichica.
È fondamentale che non solo il paziente ma anche l’animatore riesca ad esprimersi, nel gioco, con spontaneità, afferma Rosati, poiché “Il suo scopo non è la sistematica interpretazione da parte del terapeuta né la ricerca immediata di un senso, ma il gioco stesso: se lo psicodrammatista, realizzando questo teatro, riesce a contenere il gioco, cioè a comprenderlo senza spiegarlo, sarà ripagato dall’insight del paziente che fornirà egli stesso le interpretazioni” (ibidem, pp. 585-6). L’interpretazione infatti rischia di uccidere il sogno, la fantasia poiché, dice Hillman, è nel mistero che essa trova la vita. Come nei culti terapeutici di Esculapio era fondamentale il sognare, non l’interpretazione del sogno, così i sogni, le fantasie, le immagini che prendono vita nello psicodramma, specialmente nel momento del gioco, hanno dei propri rituali, una propria logica alla quale il terapeuta non può sovrapporre la propria poiché rischierebbe di ucciderela vitalità simbolica delle immagini. Con questo non si vuoleescludere la ‘presa di coscienza’ dal campo della riflessione psicologica. Il passaggio dalla parola al gioco, dalla narrazione delle proprie storie alla rappresentazione concreta di esse, scrive Rosati, “può permettere una combinazione dialettica dei due approcci: quello analitico tradizionale, basato sul primato dell’Io e sulla capacità di giudizio razionale, e quello attivo, che enfatizza l’esperienza piena e diretta delle immagini e delle emozioni invocata da Hillman” (ibidem, p. 593).
Nel gioco la rêverie terapeutica si svolge all’interno di un gruppo di partecipantiche accompagnano la drammatizzazione, anche con interventi di doppiaggio, e che consentono al ‘sognatore’ di oggettivare la ‘creazione onirica soggettiva’. Avviene così il necessario confronto con l’Altro, con l’altro fuori e dentro di noi. Caratteristica fondamentale del gioco infatti è quella dello scambio dei ruoli.
Nella prima parte del gioco il protagonista sceglie gli altri personaggi della sua storia e recita la parte di se stesso, dell’io; nella seconda parte si trova a giocare un altro ruolo nell’ambito della stessa storia, quello che l’animatore riterrà più opportuno perché più problematico da far emergere e più difficile da accettare per l’io. In questo modo emergono le immagini che interagiscono nel palcoscenico allo stesso tempo concreto e metaforico dello psicodramma in cui l’anima si differenzia e si mostra nelle sue mille sfaccettature.
Jung dice che l’anima per esistere ha bisogno della sua altra parte, che si trova sempre in un ‘Tu’, ed è attraverso il ‘Tu’ che è possibile conoscere se stessi. Nel gioco dello psicodramma si attua questo processo attraverso il quale si dà vita alle immagini, alle fantasie latenti che vivono in forma teatrale, che diventano esperienza artistica, che parlano il linguaggio dell’anima. Scrive Hillman: “… niente colpisce l’anima, niente le dà tanto entusiasmo, quanto i momenti di bellezza nella natura, in un volto, un canto, una rappresentazione, o un sogno. E sentiamo che questi momenti sono terapeutici nel senso più vero: ci rendono consapevoli dell’anima e ci portano a prenderci cura del suo valore. Siamo stati toccati dalla bellezza” (Hillman, Politica della bellezza, p. 87). Bellezza significa assumere, prendere a cuore, interiorizzare, divenire intimi e quindi, nell’atto teatrale, si compie un atto terapeutico ed estetico artistico perché si realizza la bellezza dell’anima prendendosi cura dell’anima.
Anche Aristotele si era reso conto dell’effetto catartico che la rappresentazione teatrale poteva provocare nello spettatore. Parlava di catarsi estetica che vuol dire ‘purificazione’ del corpo e dell’anima, come per gli iniziati ai misteri Eleusini. Moreno estende questo effetto dallo spettatore all’attore. Ma ogni singolo attore del teatro dello psicodramma, lo abbiamo visto, porta in sé un altro teatro interiore, il teatro psichico in cui attrici sono le immagini dell’anima. La purificazione estetica quindi va estesa anche alle immagini che, come adepti ai misteri, trovano nello psicodramma, nel sacro temenos (il recinto sacro, non a caso i partecipanti al gruppo siedono in cerchio), il luogo in cui purificarsi per accedere alla sacralità del rito.
Il gioco come rite d’entrée
Ogni membro dello psicodramma ripercorre le orme del neofita che si prepara a diventare iniziato. Si appresta ad entrare nel tempio dei Misteri nei quali l’io diurno vacilla lasciando il posto alle immagini mitiche, nei quali l’ordine, la perfezione e la ricerca di spiegazione cedono il posto al caos, all’imperfezione, alla pura intuizione. Per questo, pur frequentando assiduamente gruppi di psicodramma, molte persone hanno difficoltà a mettersi in gioco, a superare le resistenze dell’io, ad entrare realmente da adepti nel rito collettivo. Nei riti in onore di Iside era necessario purificarsi nell’acqua e nel fuoco prima di entrare nella cerchia degli adepti. È quindi necessario liberarsi degli abiti dell’io eroico, erculeo, posare la spada prima di incontrare le anime del mondo infero.
Attraverso il gioco il rito raggiunge il suo apice, si completa, il libro della vita si dischiude e le immagini si animano assumendo sembianze corporee. Il momento del gioco, con la sua messa in gioco delle immagini che recitano le loro storie sul palcoscenico dello psicodramma, non può non far pensare all’immaginazione attiva di cui parlava Jung. Tutto iniziò quando, falliti i tentativi di trovare nell’infanzia la causa delle sue inquietudini, Jung disse: “’Dal momento che non so nulla, farò solo tutto ciò che mi viene in mente’. Così, coscientemente, mi abbandonai agli impulsi dell’inconscio” (Jaffé – a cura – Ricordi Sogni Riflessioni di C.G.Jung, p. 215). Cominciò, nei ritagli di tempo, a costruire casette, castelli, portali, archi in pietra, il gioco che da bambino lo aveva tanto appassionato poiché “Il fanciullino è ancora presente, e possiede quella vita creativa che a me difetta” (idem), scrive Jung. Benché egli sapesse che attraverso quel gioco di bambino stava nutrendo una parte di sé dimenticata, sentiva forte la resistenza dell’io che percepiva come “una esperienza dolorosa e umiliante sentirsi costretto a mettersi a giocare come un bambino!” (ibidem, p. 216). Ma presto scoprì che era quella la strada da seguire, che il gioco delle costruzioni costituiva solo il principio, il rite d’entrée necessario perché nascesse ed avesse il suo corso il fiume delle fantasie. Successivamente si rivolse alla pittura, alla scultura per cercare il varco, il passaggio concreto e allo stesso tempo metaforico per accedere alle sue fantasie. Non a caso scelse l’arte, espressione massima di libertà e fantasia. Ebbe bisogno, come direbbe la Von Franz, di maneggiare materialmente degli oggetti concreti per dischiudere le porte dell’anima, e dell’arte come rituale di entrata, come avviene anche nel gioco dello psicodramma nel quale il corpo rappresenta l’elemento materiale e la drammatizzazione la forma artistica.
Una volta aperto il varco Jung vide che: “Una catena di rappresentazioni di fantasia si sviluppa e assume gradualmente un carattere drammatico: il processo passivo diviene un’azione. Dapprima essa consiste di figure proiettate, e queste immagini vengono osservate come scene su un palcoscenico. In altre parole, sognate a occhi aperti. C’è, di solito, una marcata tendenza a godersi semplicemente questo spettacolo interiore, (…) ciò che si rappresenta sul palcoscenico rimane ancora un processo di sfondo; non tocca l’osservatore in alcun modo: e quanto meno lo tocca, tanto minore sarà l’effetto catartico di questo teatro privato. Il pezzo che viene messo in scena non vuole essere solo guardato con imparzialità, vuole costringere alla partecipazione. Se lo spettatore capisce che è il suo stesso dramma che si sta rappresentando sul palcoscenico interiore, non può restare indifferente alla trama e al suo scioglimento; si accorgerà, via via che gli attori si succedono e che l’intreccio si complica, che (…) è l’inconscio che si rivolge a lui e fa sì che queste immagini di fantasia gli appaiano davanti. Si sente perciò costretto, o viene incoraggiato dal suo analista, a prendere parte alla recita” (Jung, Mysterium Coniunctionis, 14, pp. 495-6).
La Von Franz, in un articolo sull’immaginazione attiva, si sofferma su fenomeni di intenso coinvolgimento emotivo legati alla presenza materiale di oggetti. Porta l’esempio del rituale di mangiare l’ostia, il corpo del Cristo, durante la messa, metafora concreta della comunione, della congiunzione con Dio. Lo definisce uno hieros gamos, un evento sincronico al quale è possibile accedere, secondo la saggezza cinese, soltanto ponendosi con un atteggiamento di sincerità totale che per i cinesi coincide con l’atteggiamento giocoso (cfr. Von Franz, L’immaginazione attiva, p. 17). È proprio nel gioco che, come era accaduto a Jung, si realizza il momento di maggior congiunzione tra psiche e materia ed il momento di maggiore creatività poiché le personalità della psiche acquistano un corpo per parlare e per muoversi mostrandosi nella loro vera essenza con sincerità come dice la Von Franz, “in trasparenza”, come direbbe Hillman, senza intromissioni da parte dell’Io eroico della vita diurna.
Non a caso una nota immagine alchemica, il ludus puerorum (cfr. in Jung, Psicologia e Alchimia, p. 198, fig. 95), era considerata dagli alchimisti metafora dell’opera. L’opus alchemica è un’operazione difficilissima e delicatissima da realizzare, che, come lo psicodramma, coinvolge anima e corpo, in cui le sostanze materiali che vengono lavorate rappresentano la metafora corporea delle trasformazioni psichiche dell’alchimista. Diviene però un ‘gioco da bambini’ per chi possiede la chiave della Sapienza (cfr. Calvesi – a cura -, Arte e Alchimia, p. 20).
È nel gioco che si può ritrovare la fantasia e la creatività dell’infanzia, un’operazione difficile, come lo fu per Jung, che per molti è addirittura impossibile. Mi è infatti capitato di osservare in alcuni gruppi che per determinate persone è veramente difficoltoso mettersi in gioco. Pur essendo chiamate a giocare, non riescono a far vivere le immagini psichiche, ma sono presenti soltanto fisicamente e attraverso l’io diurno. Alla domanda dell’animatore: “Come ti sei sentito nel ruolo? Che sensazioni hai provato?”. Rispondono: “Normale… non ho provato nessuna sensazione…”.
Anche gli alchimisti, parlando della loro arte finalizzata alla trasformazione fisica dei metalli, ma soprattutto psichica dell’anima, la ritengono un’arte riservata a pochi. Scrive Fulcanelli, un grande alchimista:
“Noi scriviamo per tutti,
ma non tutti possono essere chiamati a comprenderci,
perché ci è interdetto di parlare più apertamente”
(in Zecchini – a cura -, Alchimia, p. 3).
L’alchimia è un’arte esoterica, nascosta alle grandi luminosità del diurno. È un’arte che ha delle proprie precise scansioni temporali lontane dall’ingordigia di Chronos che divora i suoi figli, che richiede lentezza, nella quale è permesso anche dilettarsi a giocare, e pazienza, perché un minimo errore può pregiudicare tutto il lavoro, che tende al raggiungimento della meta, l’oro dei filosofi. Ma la meta è anche l’opera stessa, il ‘gioco’ trasformativo, come lo è per lo psicodramma. Anche lo psicodramma, una volta varcata la soglia, diviene un luogo nascosto, riservato ai soli eletti, in cui il tempo assume una dimensione altra, assoluta, poiché si ha a che fare con l’anima.
Nel teatro dello psicodramma ad ogni incontro
sono messe in scena le immagini della psiche che si nutrono di sé e della loro
bellezza, che nutrono l’anima coniugando insieme in un singolo atto
intuitivo le loro due nature estetica e terapeutica, facendo vivere l’anima
nella sua autenticità e bellezza, entrando in contatto e divenendo parte
dell’Anima Mundi.
CONCLUSIONE
Per quanto tu percorra l’intero cammino
non potrai raggiungere i confini dell’Anima,
tanto è profonda la sua natura (Eraclito).
Moreno disse a Freud che nel suo teatro si imparava a sognare e a recitare la parte di Dio. Ho voluto ancora una volta citare questa frase per concludere il nostro viaggio nello psicodramma che, lo abbiamo visto, anche attraverso gli aspetti più tecnici quali il setting, la disposizione in circolo, le scansioni temporali, l’alternanza tra le figure dell’animatore e dell’osservatore, la drammatizzazione… ha in sé un valore simbolico. Laddove il simbolo, diceva Jung, è ciò che non abbraccia e non spiega, ma accenna, al di là di sé stesso, ha un significato ancora trascendente, inconcepibile, oscuramente intuito, che le parole del nostro linguaggio non potrebbero adeguatamente esprimere. Ha un linguaggio metaforico che appartiene al divino. Si tratta del numinosum, della manifestazione dell’archetipo che determina nel soggetto uno stato di profonda emozione. In senso figurato, scriveva Otto, si tratta dell’effetto che il ‘gesto’ della divinità provoca in chi la osserva.
Forse Moreno aveva intuito la presenza del divino dentro di noi. Nonostante il suo psicodramma sia molto differente dallo psicodramma che oggi viene realizzato negli studi di psicoanalisti provenienti dalle più disparate formazioni teoriche, la sua frase è molto attuale, soprattutto nel contesto sociale nel quale viviamo in cui la capacità di sognare e di creare immagini, di ‘fare anima’, è relegata ai luoghi di culto religioso, al lettino dello psicoanalista, oppure viene definita “stranezza” o “malattia”.
L’Anima è il mondo in cui vive il piccolo popolo che è dentro di noi, che ci allontana dal conformismo legato alla coscienza collettiva, portandoci nelle sue profondità senza tempo, in cui ancora vivono e sempre vivranno gli Dei dentro di noi. Ares, Afrodite, Artemide, Dioniso, Eros, Zeus, Era, Atena, Poseidone, Iside e Osiride, Thor, Odino… rappresentano, con le loro storie, il mito, la memoria dell’umanità che torna a vivere nel sogno, nello psicodramma, nell’amore, in ogni esperienza artistica e psicopatologica. Laddove per psico-patologia si intende il dare la parola al pathos della psiche.
BIBLIOGRAFIA
Aite P., Carotenuto A. – a cura -, Itinerari del pensiero junghiano, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Anzieu D., 1976, Il gruppo e l’inconscio, Borla, Roma.
Calvesi M. – a cura -, 1986, Arte e Alchimia, Art Dossier, n. 4, Giunti, Firenze.
Carotenuto A., 1992, Trattato di Psicologia Analitica, UTET, Torino.
Croce E., 1990 , Il volo della farfalla,Borla, Roma.
Eraclito, I frammenti e le testimonianze, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1980.
Galimberti U., 23.3.1999, Anima e cuore, Donne, La Repubblica.
Hillman J., 1972, Il mito dell’analisi, Adelphi, Milano, 1991.
Hillman J., 1975, Re-visione della psicologia, Adelphi, Milano 1983.
Hillman J., 1981, Psicologia archetipica,Enciclopedia del Novecento, vol. 5,
pp. 813-827, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma.
Hillman J., 1983, Le storie che curano, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1984.
Hillman J. 1988, Saggi sul puer, Raffaello Cortina, Milano.
Hillman J.,1999, Politica della bellezza, Moretti & Vitali, Bergamo.
Jung C. G., 1935, Fondamenti della psicologia analitica, Psicoanalisi e psicologia analitica, Opere, vol. 15, Boringhieri, Torino, 1991.
Jung C. G., 1938/54, Gli aspetti psicologici dell’archetipo della Madre, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Opere, vol. 9*, Boringhieri, Torino 1980.
Jung C. G., 1940/1950, Sul rinascere, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Opere, vol. 9*, Boringhieri, Torino, 1980.
Jung C. G., 1944, Psicologia e alchimia, Opere, vol. 12, Boringhieri, Torino, 1992.
Jung C. G., 1945/48, L’essenza dei sogni, La dinamica dell’inconscio, Opere, vol. 8, Boringhieri,Torino, 1976.
Jung C. G., 1946/55, Lettere II, MaGi, Roma, 2006.
Jung C. G., 1947/1954, Riflessioni teoriche sull’essenza della psiche, La dinamica dell’inconscio, Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino, 1976.
Jung C. G., 1955/56, Mysterium Coniunctionis, Opere, vol. 14, Boringhieri, Torino, 1989.
Laplanche J., Pontalis J.-B., 1967, Enciclopedia della psicoanalisi, Editori Laterza,1993.
Loewe E., 1995, Il cuore dell’analisi, Anima, Firenze.
Migliorati P., 1989, Teorie del gruppo e psicologia analitica, in aite p.,
Carotenuto A. – a cura -, Itinerari del pensiero junghiano, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Moreno J.L., 1946, Manuale di psicodramma, Astrolabio, Roma, 1985.
Perilli V., 2000, Corpo-mente da Freud a Jung, in perilli, v., perilli, e., Da Freud a Jung a Hillman, Samizdat, Pescara, 2003.
Perilli V., Perilli E., Da Freud a Jung a Hillman, Samizdat, Pescara, 2003.
Platone, Fedro (a), charbonneau-lassai l., 1994, Bestiario del Cristo, Edizioni Arkeios, Roma.
Platone, Fedro (b), Opere Complete, Biblioteca Universale Laterza, Roma-Bari, 1982.
Rosati O., L’attivazione dell’immagine nello psicodramma junghiano, in Carotenuto a., 1992, Trattato di Psicologia Analitica, UTET, Torino.
von Franz M. L., 1978, L’immaginazione attiva, Rivista di Psicologia Analitica, n. 1.
Zecchini V. – a cura -, 2000, Alchimia, Demetra, Varese.
Vedi anche, su questo sito, https://www.psicologia-analitica-junghiana.it/dallo-psicodramma-moreniano-allo-psicodramma-junghiano/ pubblicato su “Quaderni di cultura junghiana” n°2, 2013. Per scaricarlo clicca il link: http://www.cipajung.it/q2/13_CIPA_QDCJ_2_2013.pdf